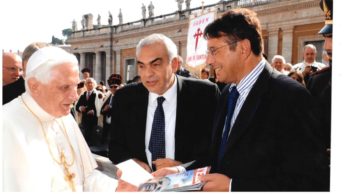
L’immigrato se ne va: «I flussi migratori sono cambiati e il fenomeno è irreversibile»
«L’immigrato se ne va» titolava qualche giorno fa la Repubblica: secondo le rilevazioni dell’ultimo censimento dell’Istat, infatti, 800 mila stranieri sono “spariti”, non risultano più residenti in Italia. I flussi migratori sembrano cambiati e se la mancanza di lavoro è uno dei motivi del cambiamento, ce ne sono molti altri, legati anche alla cittadinanza degli stranieri, come rivela a tempi.it Maria Golinelli, docente di Sociologia della società multietnica all’Università di Bologna, presso la facoltà di Scienze Politiche distaccata a Cesena-Forlì.
Se gli stranieri se ne vanno non è solo per la mancanza di lavoro?
Sicuramente la mancanza di un lavoro è uno dei fattori che può innescare un percorso discendente: dall’integrazione alla marginalità, all’abbandono dell’esperienza migratoria. Nell’articolo Franco Pittau della Fondazione Caritas sottolinea però che i dati potrebbero essere “viziati” dal tipo di rilevazione: nonostante i tanti sforzi di comunicazione è possibile che molti migranti non abbiano semplicemente risposto al censimento. Anche i dati delle cancellazioni anagrafiche non per forza ci raccontano di viaggi di ritorno: bisognerebbe poter fare una riflessione puntuale sui domiciliati, cosa che non è possibile perché non esiste una banca dati dei domiciliati. Infine, anche dai dati sui permessi di soggiorno scaduti e non rinnovati non è corretto fare l’equivalenza con il numero di rientri in patria o di emigrati in altro Paese. Piuttosto dovrebbe allarmare il numero crescente di persone che nel corso di questi ultimi 24 mesi hanno perso i requisiti per rinnovare il permesso di soggiorno e, dopo anni di vita regolare in Italia, si trovano in condizioni di irregolarità. Situazione resa ancora più drammatica dal fatto che spesso nel frattempo nel nostro Paese sono nati figli, che qui sono cresciuti, hanno studiato, hanno intessuto relazioni sociali, eccetera.
Non hanno lasciato l’Italia, dunque?
Non possiamo con certezza dire che queste persone hanno lasciato l’Italia: sicuramente a causa della crisi economica hanno perso la titolarità per una regolarità della presenza nel Paese. Per avere la residenza, infatti, bisogna avere una casa in cui si deve dimostrare di vivere effettivamente. Per mantenere una casa è necessario avere un lavoro. Se manca il lavoro il cortocircuito è facile.
I flussi migratori stanno cambiando?
La migrazione è un fatto sociale (macro) ma che si costruisce sulle storie e sulle vite delle persone. Da alcuni anni la crescita dei numeri dei migranti che entrano in Italia è dipesa in modo importante dai ricongiungimenti (oltre che dai permessi di lavoro tramite il sistema delle quote). Se 10 anni fa lo stereotipo di migrante era un uomo/giovane/lavoratore, negli ultimi anni sono arrivate in particolare donne e minori. Negli ultimi 12 mesi però la situazione è cambiata: molti migranti non hanno più i requisiti economici e abitativi per poter fare il ricongiungimento. Non solo: molti nuclei familiari stanno tornando a casa, nella speranza di superare questo periodo difficile per poi rientrare più avanti. Pochissimi però sono quelli che, andandosene, rinunciano al permesso di soggiorno. Si assentano per sopravvivere e restano fuori il massimo possibile per non perdere i requisiti del rinnovo. Si sta comportando così soprattutto chi ha il permesso di soggiorno di lunga durata (ex carta di soggiorno). Resta in Italia il padre e i figli maschi maggiorenni, coloro che in qualche modo hanno possibilità di sopravvivere e di lavorare anche solo saltuariamente. Il resto della famiglia rientra.
Un discorso che vale per tutte le nazionalità?
C’è un elemento che oggi consideriamo poco. I rumeni, quando si parla di immigrazione, sono trattati, nel discorso pubblico e nell’immaginazione collettiva, come tutti gli altri. Ci si dimentica che invece sono europei a tutti gli effetti. Infatti i finanziamenti per l’integrazione dei cittadini stranieri non ammettono azioni rivolte o che includano cittadini rumeni. La Romania non è il Marocco, è Europa. È facile andare e venire. L’iter per il soggiorno è semplificato rispetto agli extra-comunitari. Si può vivere in Italia e lavorare qui, ma curarsi in Romania senza grandi difficoltà (e a costi minori). I figli studiano in Romania, i genitori sono pendolari dall’Italia. Questo fenomeno ha cambiato i flussi migratori negli ultimi 10 anni in modo considerevole.
Un’altra novità amministrativa “silenziosa” ha modificato gli arrivi ed i ritorni da un Paese molto presente in Italia: dal 2011 per venire in Italia per un periodo massimo di 3 mesi dall’Albania non serve più il visto. Gli albanesi hanno scoperto una nuova forma di migrazione-pendolare, che ha modificato il modo di intendere la migrazione e dà una nuova forma ai flussi migratori.
Da operatrice sul campo, quali dati registra, quali problemi sorgono?
Tutto quello che sta succedendo genera incertezza nelle prospettive di vita di persone che avevano scommesso sul proprio futuro e fatto un investimento (emotivo e non solo economico) notevole. Il dramma più grande è quello dei minori che hanno vissuto la maggior parte della propria vita, se non tutta, in Italia e si trovano in balia degli eventi e a emigrare nuovamente o a vivere per la prima volta l’esperienza migratoria, però verso il Paese dei propri genitori (un salto indietro, non in avanti).
Può farci qualche esempio?
M. era un inquilino degli appartamenti che gestisce la mia cooperativa. La sua impresa ha smesso di pagargli lo stipendio per mancanza di liquidità. È tornato in Kurdistan. Partendo mi ha detto: «Dopo 7 anni in Italia là posso fare tutto». Prima ha mandato a casa S., la moglie, ed il figlio di 1 anno. Poi è partito anche lui. Prima di tornare è passato dalla Germania, per vedere se c’era qualche opportunità in più, ma alla fine è tornato in Kurdistan. Però non rinuncia alla sua avventura Italiana e tornerà in tempo per rinnovare il permesso di soggiorno, così mi ha detto partendo. Remida invece è un progetto di Rimpatrio Volontario Assistito in cui anche la mia cooperativa è coinvolta. Chi decide di tornare nel Paese di origine viene aiutato ad avviare una nuova attività economica. Partendo però il migrante deve rinunciare al permesso di soggiorno. È difficilissimo convincere le persone a partire per sempre, a dichiarare fallita definitivamente la propria esperienza migratoria, chiudere ogni possibilità di ritorno.
Giuseppe Scidà sul nostro giornale aveva suggerito la proposta di “scegliere” gli immigrati; è ancora attuale come paradigma per una convivenza equilibrata?
Con il sistema dei “decreti flussi” l’Italia di fatto già sceglie a quali Paesi dare l’opportunità di partecipare alla “lotteria” delle quote. Questo fa sì, ad esempio, che ad ogni decreto entrino in Italia migliaia di marocchini e pochissimi senegalesi, burkinabe, bengalesi…. anche se molti datori di lavoro, in tempi in cui il lavoro c’era, sarebbero stati interessati a “chiamare” operai da questi Paesi. La selezione sul profilo professionale personale è fatta, nel sistema delle quote, dal datore di lavoro che “chiama”. Chi, invece, non è in nessun modo “selezionato” è chi arriva con ricongiungimento familiare. Francamente non so dire cosa si possa fare in più per selezionare. È anche vero che esistono già quote preferenziali per profili di alto livello o per persone che nel Paese di origine hanno seguito percorsi formativi specifici finanziati dall’Italia.
Quali sono gli ostacoli maggiori?
Una cosa che oggi ostacola il percorso di molti migranti è l’iter difficile del riconoscimento dei titoli di studio. Una laurea o un Phd conseguito all’estero non vale nulla in Italia. Esiste un capitale umano di altissimo livello portato dai migranti, ma non è valorizzato. Qualche esempio? E. è ingegnare informatico con PhD conseguito in Nigeria, qui fa l’elettricista. J. in India era una pediatra nell’Ospedale della sua città, qui è disoccupata. L. era preside di una scuola in Ucraina, qui lavora come mediatrice interculturale. L. era dirigente delle poste in Romania, qui ha aperto un’impresa di pulizie.
Cosa ne pensa della proposta di conferire la cittadinanza italiana ai figli degli stranieri nati in Italia? Come si regola la materia?
Non sono una giurista, ma non bisogna esserlo per riconoscere la necessità e l’urgenza di correggere la situazione. Nel nostro Paese un ragazzo nato qui da genitori stranieri a 18 anni e 1 giorno è un adulto che deve mantenersi da solo per non rischiare di perdere il permesso di soggiorno e diventare irregolare. Per 18 anni ha vissuto, consciamente o meno, l’illusione di essere come i propri coetanei: italiano. Con la maggiore età si scopre straniero. Oltre al dramma personale c’è anche un aspetto sociale: l’investimento culturale e sociale che il Paese fa crescendo questi ragazzi è vanificato dall’impossibilità, soprattutto in questo periodo economicamente difficile, di poter vivere da adulti a 18 anni. Scuola, assistenza sanitaria, partecipazione associativa, meriti sportivi ipotecati con un permesso di soggiorno da rinnovare anno per anno. Vi invito a leggere un pò di esperienze dei ragazzi di Seconde Generazioni (www.secondegenerazioni.it): il dramma delle prime impronte digitali, i documenti, la difficoltà a trovare un lavoro, gli amici che vivono la propria gioventù in modo spensierato senza avere l’ansia di essere fermati per strada dalle forze dell’ordine per un controllo e di essersi dimenticati a casa il permesso di soggiorno e per questo rischiare una segnalazione e, a volte, anche di perdere tutto.
Gli immigrati regolari in Italia sono ancora più di 5 milioni, pari all’8,2 per cento della popolazione totale. Sono pochi?
Quello migratorio è un fenomeno sociale e storico non reversibile. Può avere un andamento non lineare, ma questo non significa che sia reversibile. Anche se guardassimo al puro aspetto demografico italiano, ci renderemmo conto che se la popolazione italiana cresce, o meglio che se non diminuisce, è per effetto dell’immigrazione. Però non ne farei una questione solo di numeri. È necessario garantire una vita dignitosa alle persone, italiane o di origine straniere che siano. La società multietnica ha un futuro virtuoso solo se non si declina in termini di guerra tra poveri per aggiudicarsi scarse risorse e opportunità. La strada è ancora lunga.
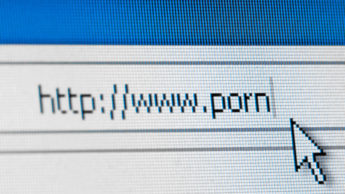


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!