
«Guareschi non criticava solo i “trinariciuti” ma qualunque cosa andasse contro l’umano»
«Vorrei suscitare la curiosità dei lettori per la sterminata e profonda produzione di Giovannino Guareschi». Così in quarta di copertina scrive Walter Muto, presentando il suo libro “Guareschi, l’umorismo e la speranza”, piccola antologia commentata, edita da Marietti 1820. «La mia passione per Guareschi arriva dalla lettura delle sue opere, prima di tutto quel “Mondo piccolo” di don Camillo e Peppone, e poi le altre pubblicazioni come “Racconti familiari”». Così commenta l’autore del saggio a tempi.it. «Poi, qualche anno fa per il Meeting di Rimini, insieme a Carlo Pastori, Paolo Gulisano ed Enrico Beruschi, abbiamo messo in piedi un spettacolo dedicato a Giovannino, e sempre più ho voluto approfondire la sua figura, come scrittore, uomo anche di satira politica, che ha pagato con il carcere alcune sue denunce, nei primi anni dell’Italia post-fascista. È con la lettura di “Italia provvisoria”, una sorta di documentario personale pubblicato da Rizzoli proprio nell’immediato dopoguerra, tra una latente guerra civile, il referendum e le elezioni del ’48, che mi è venuta voglia di mettere insieme tutte le mie riflessioni».
La prima parte del libro è dedicata al Guareschi in bilico tra le sue peripezie durante la guerra, gli interventi sull’attualità politica e la sua figura di scrittore.
Guareschi è sempre stato personaggio pubblico: attraverso le pagine prima del “Bertoldo” e poi del “Candido” dava i suoi giudizi pungenti, spesso nella sintesi dei suoi disegni e poi, naturalmente, anche con racconti. Non aveva paura di raccontare verità scomode, che gli procurarono grane e furenti polemiche. I presunti conflitti di interesse di Einaudi e poi la pubblicazione di lettere “top secret” autografe di De Gasperi gli costarono più di anno di carcere.
Il libro, poi, indaga sull’umorismo dello scrittore, sulle sue radici. Con un approfondimento su “Mondo piccolo”.
Qualcosa che non è stato valorizzato abbastanza, è questo “climax” profondamente cattolico. Ho voluto entrare anche nelle ragioni teoriche che Guareschi esprime nella premessa di “Italia Provvisoria” e di una conferenza che tenne a Lugano, nel 1951, che non venne mai pubblicata. Lì risulta lampante che l’umorismo di Guareschi è cristiano, fa parte da un annuncio evangelico: “Non fare agli altri, quello che non vorresti fosse fatto a te”, cioè puoi contestare un costume sociale, ma mai la persona.
Nel libro, lei fa un curioso parallelismo tra Guareschi e Flannery O’Connor, scrittrice americana, cattolica, autrice di racconti molto originali e mai scontati.
È stata una suggestione che mi è venuta in mente leggendo una prefazione da una raccolta di racconti di Guareschi, dove si faceva un brevissimo confronto tra un racconto e l’opera della O’Connor. Poi ho voluto approfondire e, nonostante la diversa nazionalità, mi ha colpito il fatto che in alcune delle storie di Giovannino e praticamente in tutti i racconti dell’americana il soprannaturale, la Grazia, fa un ingresso nelle vicende umane sempre realista, verosimile, non è mai un intervento spettacolare od horror. Entra nella vita degli uomini e costringe al suo riconoscimento. Spesso in Guareschi questo passaggio è rappresentato dal Grande Fiume, il Po, che ad un certo punto diventa il protagonista e l’uomo deve far fronte a qualcosa che non è governabile dalle sue mani.
Scrittore, umorista, autore di satira, caricaturista e vignettista, uomo dai mille interessi, Guareschi in questi anni è come rimasto etichettato e sommerso dai luoghi comuni delle ideologie.
L’esempio lampante è stata la realizzazione di un documentario dal titolo “La rabbia”, a cura sua e di Pasolini. L’intenzione, un po’ schematica, era di far commentare fatti di cronaca sociale da destra e da sinistra. Non ebbe molto successo a suo tempo. Qualche anno fa, quando è stato riproposto restaurato ad un Festival, è apparso solo il commento di Pasolini. L’integrale probabilmente sarebbe stato politicamente troppo scorretto. A Guareschi è stata data più volte l’etichetta di fascista e di monarchico (monarchico lo era stato, in ogni caso), era comunque un uomo scomodo: criticava qualunque cosa che andasse contro l’umano, sia che venisse da destra che da sinistra. Non dimentichiamo che è stato in un lager nazista per quasi due anni. Certo si scagliò con veemenza dialettica contro “i trinariciuti” , non tanto perché fossero di sinistra, ma perché, come diceva, «versano il cervello all’ammasso», seguendo le direttive del Partito. Ecco, lui criticava questo costume.
Alla fine il libro si conclude con i ringraziamenti a lei, autografati dai figli di Guareschi, Carlotta e Alberto.
È stato un grande piacere, mi sono confrontato molto con Alberto, un uomo che ha passato la settantina, che continua a diffondere l’opera di suo padre. Ha allestito una mostra permanente a Roncole Verdi. I due fratelli sono stati molto gentili nell’aiutarmi a reperire la documentazione.
Il suo libro, come accennava, è il risultato degli approfondimenti sulla figura di Guareschi, che ha sperimentato negli spettacoli, che sta portando sui palchi teatrali. Come reagisce il pubblico?
Il pubblico reagisce sempre bene, perché Guareschi “rimane”, le persone di una certa età, ma anche i più giovani sono, alla fine, soddisfatti. Noi, in scena, approfondiamo di più l’aspetto del Guareschi famigliare, partendo dall’esperienza del lager e citiamo brani estrapolati da “Zibaldino”, “Il Corrierino delle famiglie” e “Osservazioni di uno qualunque”. Come scrivo nelle ultime righe del mio piccolo saggio: «Attraverso la vita e le opere di Giovannino Guareschi, un’Italia è tramontata e, possiamo dire, non è ancora rinata. Gli uomini hanno dimenticato che per fare grande un Paese occorre appoggiarsi su grandi ideali e su una Speranza che non muore. Che in Giovannino non è morta. Grazie a Dio».
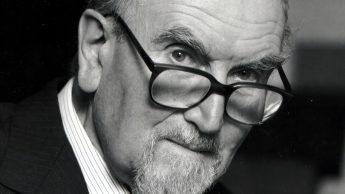


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!