
Anche il diavolo usa le Scritture


Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – Invocare Dio per legittimare il massacro di popolazioni innocenti, decapitazioni di ostaggi, stupri, kamikaze, e ogni sorta d’ignominia, è un atto sacrilego e blasfemo, che rende però l’estremismo islamista di oggi più forte che mai. Come contrastarlo? Il rabbino Jonathan Sacks, uno dei massimi teologi contemporanei, nel suo ultimo libro, Non in nome di Dio, ci prova, confrontandosi con la violenza religiosa di tutti e tre i grandi monoteismi, e conia un termine per definire questo tipo di violenza: «Malvagità altruistica». Azioni malvagie commesse da persone disposte a sacrificare la loro vita e quella altrui, come se stessero facendo «il lavoro di Dio e sembrassero felici». Le religioni trasformano gli uomini in assassini?, si chiede Sacks, sono davvero la principale fonte di violenza pur essendo allo stesso tempo fonte di amore, compassione, tolleranza, perdono?No, ci fu di peggio: nel secolo scorso il comunismo ha provocato quasi cento milioni di morti.
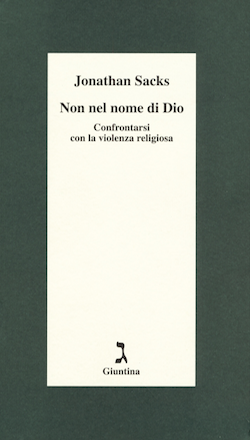 Ma è indubbio che «l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam si definiscono come religioni di pace e tuttavia tutte e tre hanno dato origine alla violenza in alcuni momenti della loro storia». Perché? Le religioni praticano il bene e la carità, alimentano la solidarietà tra i credenti, ma possono divenire spietate e crudeli verso chi dissente, vedendo l’altro solo nell’ottica di convertirlo. L’uomo tende a formare dei gruppi, scrive Sacks: «L’altruismo ci fa fare sacrifici a vantaggio del gruppo e al contempo ci porta a commettere atti di violenza contro quelle che vengono percepite come minacce al gruppo». Più di ogni altra forza la religione vincola le persone, musulmani con musulmani, ebrei con ebrei, crea gruppi identitari che entrano in contrapposizione, dividendo il mondo in un Noi e un Loro. Ma la violenza vera e propria esplode solo se la lotta si estremizza, se un gruppo religioso afferma di avere l’esclusiva del bene e crede che “tutto il male” che gli accade sia colpa dell’Altro.
Ma è indubbio che «l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam si definiscono come religioni di pace e tuttavia tutte e tre hanno dato origine alla violenza in alcuni momenti della loro storia». Perché? Le religioni praticano il bene e la carità, alimentano la solidarietà tra i credenti, ma possono divenire spietate e crudeli verso chi dissente, vedendo l’altro solo nell’ottica di convertirlo. L’uomo tende a formare dei gruppi, scrive Sacks: «L’altruismo ci fa fare sacrifici a vantaggio del gruppo e al contempo ci porta a commettere atti di violenza contro quelle che vengono percepite come minacce al gruppo». Più di ogni altra forza la religione vincola le persone, musulmani con musulmani, ebrei con ebrei, crea gruppi identitari che entrano in contrapposizione, dividendo il mondo in un Noi e un Loro. Ma la violenza vera e propria esplode solo se la lotta si estremizza, se un gruppo religioso afferma di avere l’esclusiva del bene e crede che “tutto il male” che gli accade sia colpa dell’Altro.
Cosa ha condotto le tre religioni monoteiste a una tale bellicosità? Per Sacks i monoteismi sono “fratelli in competizione” figli di uno stesso “Dio-Padre”. Ciascuna religione desidera essere l’unica erede del patto con Abramo e definisce se stessa negando l’altra. Perché si sente autorizzata a farlo? Dio, avendo scelto Giacobbe e non Esaù, Isacco e non Ismaele, innesca la rivalità tra i fratelli, operando una selezione crudele, in cui c’è il respinto e il prescelto. Per questo il cristianesimo ha operato così con l’ebraismo, e l’islam con entrambi, ribaltando il racconto biblico e sostenendo che fu Ismaele, il primo figlio di Abramo, a essere scelto, imputando agli ebrei la falsificazione del testo.
Il bisogno di immedesimazione
Ma perché Dio sceglierebbe Isacco e non Ismaele, Giacobbe e non Esaù? Dio amerebbe davvero più uno che l’altro, dando così adito alla lotta tra i fratelli per accaparrarsi il suo amore? Impossibile, dice Sacks, «la parola biblica offerta nell’amore, invita la sua interpretazione nell’amore». Tocca alle religioni interpretare se mai il racconto della Genesi in un altro modo. Devono capire che spetta a loro porre fine alla rivalità, alla lotta reciproca tra di esse. Se Lui è padre di tutti e ama tutti allo stesso modo, la nascita di Isacco non può essere vista come la destituzione di Ismaele e la scelta di Giacobbe non può significare il rifiuto di Esaù.
E se anche la scelta da parte di Dio di Israele e non di tutta l’umanità, che ha suscitato tanto risentimento nei riguardi del popolo ebraico, fosse dettata proprio dalla preoccupazione della violenza nel nome di Dio? Dio sceglie i figli d’Israele, un gruppo di schiavi liberati, disorganizzati, privi di un territorio, destinati a restare stranieri persino nella loro terra. I figli d’Israele furono monoteisti durante il paganesimo, poi non cristiani in una Europa cristiana, oggi sono una minoranza non musulmana nel Medio Oriente islamico. L’amore particolare del Dio universale per Israele è l’amore per coloro che sono diversi, e insegna ad accordare dignità e diritti a chi non è come gli altri. Per vincere la paura di chi non è simile a me, per guarire da questa violenza potenziale verso l’altro, occorre vedere nel volto dell’altro l’impronta di Dio, se non è a mia immagine è a immagine di Dio. Solo così posso accorciare le distanze tra me e l’altro, sino a divenire capace di immaginarmi come l’altro, mettermi al suo posto.
Non accettare più che qualcuno dica: “Io odio e uccido i nemici perché lo dice la mia religione”. Bisogna prendere posizione immediata contro questa predicazione dell’odio, afferma Sacks a conclusione del libro. Una religione di pace non può legittimare l’omicidio. Ci sono passi, ad esempio del Deuteronomio o del libro di Giosuè, scritti in epoche in cui il massacro di popolazioni era un fatto endemico, che, se presi alla lettera, potrebbero legittimare crimini inauditi. I testi sacri sono antichi, e la questione è come applicare la parola di “quei tempi” al mondo di oggi. Come colmare l’abisso “ermeneutico” del tempo e del divenire? «Chi traduce un verso letteralmente è un bugiardo», dice il Talmud. La lettera uccide, persino «il diavolo può citare la Scrittura per il suo scopo», sosteneva Shakespeare.
Un confronto interiore
La vera battaglia, secondo Sacks, è quella che avviene all’interno di noi, nell’anima, quando ci confrontiamo con la parola divina in un continuo lavoro critico. «Essa cambia il mondo perché cambiamo noi». Bellissime le parole del rabbino, come l’incitamento a «rendere onore alla dignità universale dell’umanità» e a «immaginarsi come Altro». Ma quando mai le parole hanno fermato le stragi? Se le istituzioni religiose avviassero un vero lavoro di bonifica dei testi sacri, sottolineando, mettendo tra parentesi, commentando tutti quei passi che possono dar adito alla violenza, le cose cambierebbero eccome. Persino la Germania, che nella prima metà del Novecento sterminò quasi un intero popolo, ora si dà un bel daffare per le genti più in difficoltà. L’importante è che paesi arabi e africani e dintorni, che dall’Europa furono asserviti e umiliati, facciano ora uno sforzo assieme a noi e desiderino la pace. E capiscano che onorare Dio in modo incessante, e assordante, è blasfemo, e che Dio dei loro reiterati salamelecchi non sa che farsene. Penso che onorare – si fa per dire – Dio in modo non solo feroce ma anche soltanto sciocco, o noioso, senza bellezza e novità, è cercare di umiliarlo. I suoi servi spesso sono i suoi assassini. Sacks è propenso a sostenere che le guerre di religione tra i popoli siano un fratricidio che parte da lontano; può essere, ma più che un fratricidio credo si tratti di un parricidio, o deicidio, che dir si voglia. I fratelli si scannano tra di loro perché non credono che Dio li ami allo stesso modo, non credono al Suo amore universale, e uccidono in suo nome, prendono il suo posto o almeno ci provano. Il Dio dell’amore e della pace è così sostituito da uomini senza vera preghiera e religione.
Foto Ansa
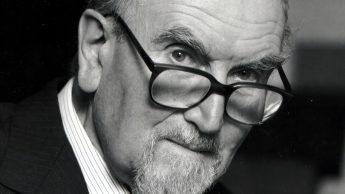


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!