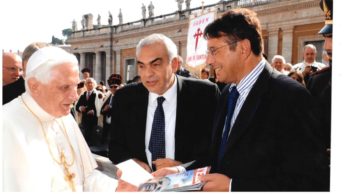
«I bambini hanno diritti. E gli adulti non hanno diritto ai bambini»

 Arrivata in Italia in occasione della Conferenza internazionale per l’abolizione universale della maternità surrogata che si è tenuta il 5 e il 6 aprile a Roma presso l’Università Lumsa, Katy Faust è una figura che merita l’attenzione del pubblico italiano. Nata a Portland, Oregon, si è laureata in scienze politiche e studi asiatici. Vive a Seattle con suo marito, un pastore battista, e hanno quattro figli di cui uno adottivo. Nel 2018 Faust ha fondato negli Stati Uniti un’organizzazione che si chiama “Them before us” (loro prima di noi). Il «them» è riferito ai bambini, la cui voce in ambito sociale e culturale è quella prevalentemente ignorata o cancellata dalle discussioni su famiglia e diritti riproduttivi e civili.
Arrivata in Italia in occasione della Conferenza internazionale per l’abolizione universale della maternità surrogata che si è tenuta il 5 e il 6 aprile a Roma presso l’Università Lumsa, Katy Faust è una figura che merita l’attenzione del pubblico italiano. Nata a Portland, Oregon, si è laureata in scienze politiche e studi asiatici. Vive a Seattle con suo marito, un pastore battista, e hanno quattro figli di cui uno adottivo. Nel 2018 Faust ha fondato negli Stati Uniti un’organizzazione che si chiama “Them before us” (loro prima di noi). Il «them» è riferito ai bambini, la cui voce in ambito sociale e culturale è quella prevalentemente ignorata o cancellata dalle discussioni su famiglia e diritti riproduttivi e civili.
Oggi aborto, maternità surrogata, procreazione assistita, divorzio, matrimoni omosessuali sono oggetto di dibattito in discussioni separate, ma si tratta di pezzi solo apparentemente irrelati di un puzzle il cui disegno complessivo si svela operando una specie di rivoluzione copernicana. Ponendo i diritti naturali dei bambini al centro dell’attenzione si guadagna una prospettiva di realtà che con autorevole ragionevolezza tiene insieme i frammenti impazziti delle relazioni umane con una proposta sfidante, ma positiva. Tempi ha incontrato Katy Faust per approfondire la sua esperienza.
Può raccontarci di come la sua storia personale l’ha portata a interessarsi ai diritti dei bambini, fino a creare un’organizzazione fondato sul messaggio “Them before us”?
Da piccola ho vissuto il divorzio dei miei genitori. Mio padre ha trovato un’altra compagna e si è risposato, invece mia madre ha intrapreso una relazione con una donna. Ho trascorso il mio tempo dividendomi tra la casa di mio padre e quella di mia madre, e li amo. Sono ancora molto legata a mia madre e alla sua compagna, quindi “Them before us” non è nata da sentimenti di rabbia o inimicizia. La mia educazione mi ha insegnato ad amare e rispettare tutti, e questa è una parte importante del nostro messaggio. Più tardi ho lavorato in un’agenzia di adozioni e ho compreso a fondo le criticità di questo istituto nell’aiutare i bambini. Sono anche diventata una madre adottiva, mi sono accorta di quanto l’adozione sia importante in termini di riparazione di storie ferite, ma mi sono anche resa conto che non sistema tutto. Ci sono cose che il mio figlio adottivo ha perso e non posso dargli.
Tutto questo fa parte della mia storia, però nessuno di questi elementi mi ha spinto a fare quello che faccio oggi. Il vero motivo è che quando gli Stati Uniti hanno cominciato a dibattere sul matrimonio degli omosessuali, ho notato un’attenzione ossessiva al punto di vista degli adulti: i loro «voglio», i loro desideri, la loro identità, le loro attese, i loro dolori, le loro battaglie. Non si trova traccia dei bambini in queste discussioni. Chi sono? Cosa diventeranno? Di cosa hanno bisogno? Cosa vogliono? Quali sono i loro diritti naturali?
La loro presenza è trascurata, eccetto che per convalidare ciò che gli adulti vogliono. Insieme a mio marito ho fatto parte di una pastorale giovanile, ci occupavamo di bambini e ragazzi delle scuole medie e superiori. Da quando mio marito è diventato pastore della Grace Church Seattle, seguiamo anche i ragazzi che frequentano l’università. Conosciamo bene il mondo dell’infanzia e dei giovani, posso dire a ragion veduta che i bambini patiscono quando le famiglie vanno in frantumi. Madre e padre non sono termini interscambiabili, un figlio ha specificamente bisogno dell’amore di una madre e di un padre e che moglie e marito si amino.
Quello che all’inizio ho notato riguardo al dibattito sul matrimonio omosessuale oggi è pervasivo in tutte le altre discussioni sulla famiglia, sulle tecnologie riproduttive, sulla surrogata, su chi ha diritto all’adozione. Sono discussioni che sempre esaltano gli adulti e ignorano i bambini.
Questo mi ha fatto decidere di cominciare a scrivere sul matrimonio, poi ho capito che alla luce dei diritti naturali dei bambini si devono tenere uniti in un unico orizzonte anche tutti gli altri temi che ho citato prima. Il dovere degli adulti è farsi carico della parte difficile delle situazioni, così che non debba gravare sui figli.
Il lettore o l’ascoltatore ormai non nota più l’assenza della voce del bambino nelle discussioni che riguardano matrimonio, fertilità, utero in affitto. Ed è come trascurare l’assenza del protagonista. Com’è possibile?
Perché i bambini non si difendono da soli. Non hanno un blog, non scrivono al governo, non sono in grado di proteggere i loro diritti, non possono pagare degli avvocati, non possono creare una lobby. E, oltretutto, il punto è che i diritti dei bambini infrangono ciò che gli adulti vogliono, tutti gli adulti. È ovvio che gli adulti tendano a non considerare la presenza dei bambini nelle discussioni, perché li sentono come qualcosa che va contro i loro interessi. Nel mio lavoro sono abituata a dire alla gente: «Dammi un po’ di tempo e vedrai che riuscirò a offenderti». Si arriva a un certo punto in cui l’interlocutore chiede: «Stai dicendo che sono io quello a dover fare sacrifici?». E intende: devo veder infranto il sogno di avere quello che voglio?
La voce dei bambini è una pretesa, esige un impegno da parte dei grandi. È agli adulti che capita una gravidanza non pianificata, e questo richiede l’impegno di ricapitolare tutta la propria vita. Per chi è sterile l’impegno è quello di fare i conti con la propria infertilità in un modo che non privi il bambino della vita, o di una madre o di un padre.
Per chi vive un matrimonio difficile la sfida è quella di non saltare la parte in cui si chiede aiuto e si prova a superare i conflitti, perché è ingiusto che i figli siano sballottati da una casa all’altra. Per chi prova attrazione per una persona dello stesso sesso il messaggio è: la famiglia è il luogo in cui il bambino sta con un padre e una madre che si amano ogni giorno, non è il sogno coronato delle proprie attrazioni romantiche. Non è facile per nessuno, ma è buono e giusto. L’unica alternativa ai sacrifici fatti dagli adulti è che tocchi ai bambini farli.

Un aspetto merita un chiarimento, quest’attenzione al bambino in un mondo adulto-centrico non è un’idolatria dell’infanzia. Finché il «grumo di cellule» è nella pancia, viene tenuto fuori dai discorsi o facilmente cancellato. Accanto a ciò, c’è anche una scena opposta. Dalla nascita in poi assistiamo a derive assurde di venerazione dei bambini. Qual è la differenza tra centralità e idolatria?
Quello che noi facciamo è difendere i diritti naturali dei bambini: il diritto alla nascita e ad avere una mamma e un papà. Non hanno il diritto ad avere tutto quello che vogliono, quando lo vogliono. Uno dei doveri dei genitori, infatti, è dare dei limiti ai figli. Non è nel best interest del bambino essere trattato da piccolo imperatore. Il nostro messaggio non è neppure sostenere che i figli siano il centro del mondo dei genitori, il centro della loro vita. Non sono idoli rispetto a cui tutto s’inchina.
Il punto fondamentale è ricordare agli adulti che sono gli unici che possono proteggere i diritti naturali dei bambini, devono farsi carico di questo perché i piccoli non possono farlo. Proteggerli non è venerarli.
Il tema della protezione ne porta a galla un altro, quello del padre. “Padri pericolosi” è il titolo di uno dei capitoli del libro che ha scritto insieme a Stacy Manning. Nell’opinione pubblica oggi prevale una narrazione molto sbilanciata sulla vulnerabilità femminile. Insistiamo sul termine «femminicidio» con il sottinteso che il maschio (il padre) sia il cattivo, il nemico. Anche lei ha l’impressione che esista questo veleno sparso per separare, per erodere la fiducia nell’impegno che è la relazione tra padre e madre? Perché abbiamo più che mai bisogno di padri?
C’è un assalto contro il marito e il padre che definirei culturale, legale, tecnologico. Culturalmente siamo passati attraverso la rivoluzione sessuale. Il femminismo ci ha insegnato che il matrimonio è uno strumento in mano al patriarcato. Finché sei sposata dipendi da un uomo, cioè non sei libera e al suo stesso livello. Questo tipo di messaggio è filtrato in modo capillare. Anche nelle serie televisive degli anni ’80 e ’90 la mamma era sempre quella intelligente, quella responsabile. Il padre era lo stupido, aveva bisogno della madre per essere messo a posto. A volte il papà era adorabile e si occupava dei bambini, ma era sempre rappresentato come il peso morto.
Legalmente siamo riusciti a ridurre il padre a un optional. Direi che negli Stati Uniti è cominciato quando, dal 1969 in poi, è stato riconosciuto il divorzio senza colpa. Ciò ha significato letteralmente dire ai padri che non è necessario che siano presenti nella vita dei figli quotidianamente e l’ago della bilancia è stato sproporzionatamente spostato sulla custodia materna.
I bambini perdono il contatto col genitore che non ha la custodia prevalente, vale a dire soprattutto il padre. Nel 40 per cento dei casi, a due anni dal divorzio, i figli smettono completamente di vedere il proprio padre.
Poi siamo arrivati al tempo dei matrimoni omosessuali e il passo ulteriore è stato quello di affermare: non c’è neppure più bisogno del padre per iniziare una famiglia. Ovviamente vale anche l’altra opzione, cioè che si può cominciare anche senza una madre, ma dal punto di vista tecnologico è più difficile cominciare una famiglia senza una madre piuttosto che senza un padre. Stiamo anche accelerando verso l’idea che non ci si debba aspettare di avere due genitori, possono essere anche tre o quattro, possono essere gruppi in cui il genere di chi vi prende parte è irrilevante. C’è solo bisogno di tanto, tanto amore e non importa se un adulto resta nella vita del bambino per una notte, un anno, dieci anni.
Ci sono davvero pochi luoghi negli USA in cui si sente dire che il padre conta. Negli anni Sessanta c’era un 5 per cento di famiglie con padri assenti o di madri single, oggi sfioriamo il 40 per cento di madri sole. Una cultura del genere è insostenibile. Non si può costruire un mondo sano senza i padri.
Sembra che oggi il tasso dei divorzi stia diminuendo, ma chi può dire cosa succederà. L’elemento importante da sottolineare è che oggi i padri che restano legati ai figli sono quelli che stanno insieme alla loro madre. I dati ci dicono che affinché il padre sia una presenza coinvolta nella famiglia, deve essere sposato con la madre dei bambini. Deve vederli tutti i giorni e questo accade quando è sposato con la madre. Il padre è cruciale, se manca non c’è sostituto.
Il padre è la roccia della fiducia, dà ai figli qualcosa che le madri non possono dare. È pura realtà.
C’è uno stereotipo accreditato per cui chi parla di famiglia naturale, diritto alla nascita, diversità di maschile e femminile, lo fa a partire da un impulso religioso. Da noi si dà per scontato che siano i cristiani a tirar fuori certe ramanzine, per difendere una certa morale. Invece lei non ha ancora nominato Dio, parla in termini politici, inteso in senso non partitico ma di «cosa umana pubblica».
Spesso quando parlo in pubblico propongo questa riflessione: se pensate alla maggiori religioni mondiali (Induismo, Buddismo, Ebraismo, Islamismo, Cristianesimo), cosa hanno tutte in comune? Sono forse d’accordo sulla natura di Dio, sull’aldilà, sui problemi del mondo e le possibili soluzioni? Non sono d’accordo su molto, ma concordano sul fatto che un uomo si debba legare a una donna prima di fare figli con lei e stare con lei per tutta la vita. Perché su questo sono d’accordo? Perché osservano la realtà dell’umano.
A tal proposito, cioè in merito a osservazione e realtà, c’è il tema della narrazione. Assistiamo sempre più spesso al tentativo che le parole creino realtà che non esistono, piuttosto che essere specchio di quello che c’è. Come secondo passaggio, la parola diventa strumento di conflitto e non di dibattito. Come si fa a tenere strette le redini di un discorso che sia chiaro ma non aggressivo, che sia leale con la realtà senza il timore di essere additati come violenti?
La chiarezza di fondo, nel nostro caso, è che difendiamo i bambini. Le parole sono sempre in difesa loro, non contro qualcun altro. Raccontiamo storie reali, portiamo l’attenzione sui diritti naturali, mettiamo in fila i dati esistenti sui bambini. È più che mai necessario essere voci che difendono qualcosa, spostare il discorso su un punto che sostiene qualcosa di inamovibile. Fa molta differenza porsi non «contro» la surrogata ma come interlocutori che portano l’attenzione sul bene indiscutibile che è per il bambino avere un padre e una madre, perché la sua identità biologica dipende da loro. E la verità, dunque, è che la surrogata è un limite terribile per tutti gli adulti. È ingiusto per tutti gli adulti infliggere una ferita ai bambini, separandoli dalla madre.
Oppure, se qualcuno viene da me e mi chiede: «Perché non posso divorziare?», rispondo che può farlo, ma deve essere consapevole del fatto che sta togliendo il peso dalle sue spalle per metterlo su quello dei suoi figli. Non ti impedisco di fare qualcosa, ma ti invito a essere davvero onesto su quello che fai. Qualsiasi questione, da cosa sia il matrimonio o il divorzio, all’uso delle tecnologie riproduttive, alla legittimazione della poligamia, al diritto delle coppie omosessuali di adottare, si mette a fuoco molto chiaramente quando ci si pone a servizio di qualcosa, che nel nostro caso sono i bambini.
Mi rendo conto di avere una posizione che è sfidante verso gli adulti, però non in modo da finire nel senso unico del «sono contro». Perché essere contro finisce per essere percepito come «ti odio».
È una sottolineatura sostanziale che Chesterton sintetizzò affermando: «Il vero soldato non combatte perché odia chi ha di fronte, ma perché ama chi è alle sue spalle». Il tema dell’amore è cavalcato con grande enfasi dal mondo LGBT, con cui il confronto, però, finisce spesso per essere una guerra. Un incontro sembra possibile solo se si accettano le etichette imposte. Nei suoi scritti e discorsi s’intravede uno sforzo costante a uscire dalla gabbia degli animi infiammati, come si scardina il cortocircuito del “noi contro loro”?
Esiste qualcuno che non ama Chesterton? Il punto è esattamente quello della citazione. Talvolta si riesce a non finire sulle barricate, ma non sempre. Ci sono tanti esponenti del mondo LGBT che odiano il messaggio che propongo e non mi accettano. Va bene, non devo essere in pace con tutti. Quello che devo fare è difendere i bambini. Estrapoliamo dal contesto religioso un’indicazione che vale anche al di fuori, San Paolo scrive nella Lettera ai Romani: «Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini». Abbiamo questa responsabilità, per tutto ciò che dipende da noi. Ma la pace non è solo in mano nostra, spetta anche a loro.
Lutero, che so essere distante dalla vostra sensibilità, affermava: «L’unità quando è possibile, ma la verità a tutti i costi». È bello adoperarsi per l’unità in tutti i casi in cui si riesce a gettare un ponte con i nostri fratelli del mondo LGBT, ma non al costo di barattare la verità. Sfortunatamente molti del mondo arcobaleno offrono una mano all’unità solo se noi sacrifichiamo la verità. Smettono gli attacchi solo se rigettiamo del tutto la verità. E non è un’opzione. Ci sono delle verità che dobbiamo difendere, incuranti dell’odio che ne riceveremo.
Foto iniziale da Unsplash
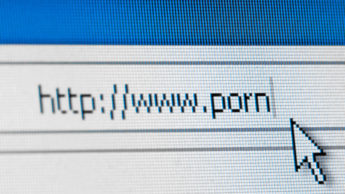


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!