
Enrico Brizzi racconta l’alba del calcio, quando i campioni morivano in guerra
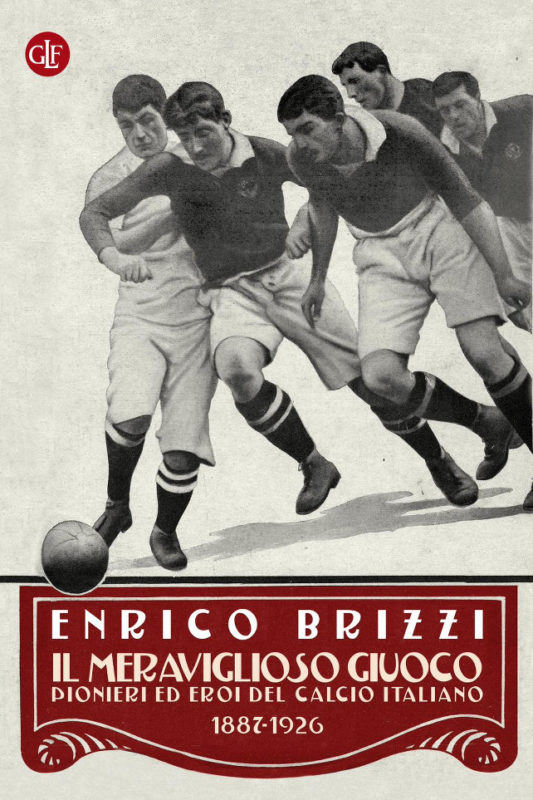
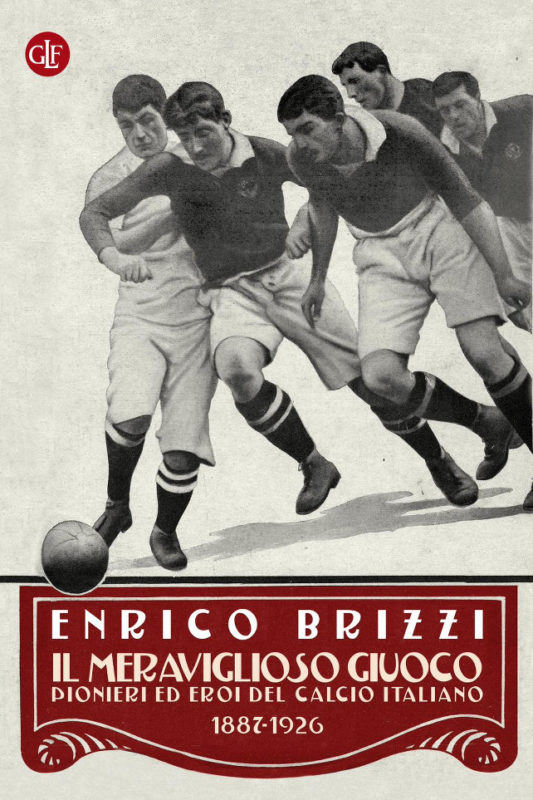 Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)
Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)
La festa finì domenica 23 maggio 1915 quando accadde qualcosa che nessuno aveva mai visto accadere: trasfigurati «in gravi banditori dei tempi andati», gli arbitri presero la parola all’unisono sui diversi campi per annunciare al pubblico che la Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberava la sospensione immediata dei tornei di ogni ordine e grado in vista dell’entrata in guerra contro l’Austria-Ungheria. «All’inizio la gente non capì che nel provvedimento erano incluse anche le partite del pomeriggio, e iniziò a realizzare cosa stava succedendo solo quando gli arbitri, da Nord a Sud, rientrarono negli spogliatoi portando con sé i palloni». Nel momento in cui viene consegnata la dichiarazione di guerra ai rappresentanti austriaci Enrico Brizzi ha già reso bell’e vivi, incontrabili, quasi amici, quel mazzo di galantuomini e di personcine di paese che stanno ascoltando attoniti gli arbitri in giacchetta nera d’ordinanza, ed è per questo che non si può proprio parlare del suo ultimo libro, Il meraviglioso giuoco (ed. Laterza, 278 pagine, 19 euro), del primo trentennio della storia del calcio in Italia e nemmeno della Grande Guerra senza parlare di cosa accadde quando il signor Edoardo Bosio, impiegato in una ditta inglese, fece ritorno da Londra a Torino con un pallone di cuoio in mano, o di una sera di fine estate che vide riunirsi un gruppo di intraprendenti affaristi inglesi a Genova; dei fratelli Rampini e di Guido Ara, del dottor Spensley e dell’avvocato Mauro.
Dev’essere anche un po’ colpa di quell’impasto di suolo italico che gli rimane sotto le suole mentre macina capitoli e chilometri con la caparbietà di un pellegrino dell’anno Mille: quando un Brizzi arriva in libreria aprendo, immancabili, i valzer delle ristampe, si finisce sempre per spedire la fantasia al pascolo sotto i portici della sua Bologna (dove è nato, cresciuto e insieme ad amici e colleghi ha animato la casa editrice Italica), tra le aule dell’Alma Mater (dove, ancora matricola, s’è inventato il best seller Jack Frusciante è uscito dal gruppo, e da cui è uscito laureato vent’anni, dodici romanzi e quattro figliolette dopo), lungo la via Francigena (solo per citarne una percorsa e ripercorsa con la sua batteria di escursionisti pedibus calcantibus, gli Psicoatleti).
Si viaggia un po’ anche noi, insomma, ci si chiede dove si è già incontrato e perché Alex, Ermanno e Lorenzo Pellegrini – indimenticati protagonisti di Jack Frusciante, Bastogne e L’inattesa piega degli eventi – ci siano così familiari. Il meraviglioso giuoco non fa eccezione, tutt’altro. Analfabeti del fuorigioco: convincetevi ad aprirlo e scoprire cosa accadde quel giorno del 1889 in cui a Torino, in piazza Carignano, un uomo coi baffi scuri chiamato Federico Nietzsche si gettò piangendo al collo di un cavallo, coprendolo di baci.
L’orgoglio della stracciona
«In quegli anni una certa dose di follia e spirito anticonformista erano necessari anche per rincorrere in calzoncini una palla», spiega a Tempi Brizzi, 40 anni e quella disposizione tutta emiliana a farsi sempre capire al volo, parlasse pure di quello che vuole, perché ogni volta che inforca una tastiera finisce sempre per regalarci una grande storia d’amore. Come quest’ultima, dedicata all’amore più «duraturo, viscerale, struggente», l’amore per il football che prende un’Italia come solo lui sa raccontarla, animata e vivente, coi suoi bei re Mitraglia (Umberto I) e Sciaboletta (Vittorio Emanuele III), i soprannomi eternanti, i retrobottega, le borracce di cognac tracannate in trincea, un’Italia grondante di umanità capaci di grandi verità con parole molto semplici.
Prendiamo questa, attribuita a Guido Ara, mediano della Pro Vercelli e della Nazionale: «Il calcio non è un gioco per signorine, un vecchio adagio da bar dello sport vagamente sessista dietro cui si cela una delle grandi verità del tempo che oggi ci piace identificare come l’età d’oro del calcio. Parlando di signorine Ara tirava in ballo con arguzia contadina i vecchi padroni del calcio italiano: la sua Pro Vercelli era una squadra di uomini umili e orgogliosi, figli della provincia e della cultura del lavoro: potevano dire lo stesso i figli dei ricchi commercianti e dei banchieri che avevano giocato nel primo Genoa o i liceali torinesi del D’Azeglio, gli studenti dei collegi svizzeri e britannici che riempivano le altre squadre senza spessore?». Ecco per Ara chi erano le “signorine”, «vani gagà senza spessore: nessuno di loro si era ritrovato a vendere i sigari che il presidentissimo Luigi Bozino concedeva quale premio-partita come fece Carlo Rampini per aiutare il collega Carlo Corna, povero in canna con un fratello malato. Nessuno tra le signorine vantava compagni di squadra tanto poveri da meritare la carità. Eppure la Pro Vercelli, stracciona ma orgogliosa, le aveva messe in riga tutte».
Piace proprio raccontarlo così, lo sport per gentiluomini che finisce per diventare uno strumento di riscatto sociale da Nord a Sud. Dove i meno abbienti si confrontano con i signorotti, mamme e sarti cuciono casacche d’ogni colore e i mocciosi si fanno beffe di campioni navigati.
Undici mocciosi contro l’Inter
Come il 24 aprile 1910, quando l’Inter si presenta in Piemonte e la Pro Vercelli, in accesa polemica con la Federazione, schiera gli undici ragazzini, alti un soldo di cacio, della giovanile: tra di loro, il marmocchio Alessandro Rampini, fratello più piccolo del titolare Carlo, che con ghigno beffardo consegna alla squadra dello slanciato e stupefatto capitano Virgilio Fossati lavagna e gessetti, «così potrete segnare i record della vostra grande giornata». Celebre è la cronaca della partita, che vide gli interisti vincere 10 a 3 dopo aver sopportato «novanta minuti di forche caudine, esposti al dileggio del pubblico e alle buffonate dei giovani avversari», così come la storia del “Rampini II” che seguendo le orme del fratello, divenne un giocatore bandiera del club. Meno noto, invece, è che tra Carlo e Alessandro vi fossero altri tre fratelli, tutti calciatori, alcuni dei quali militanti nella stessa squadra, qualcuno morto in guerra, un altro in un conflitto a fuoco tra rossi e neri negli anni Venti. «La storia dei Rampini è quella di un calcio annientato da una guerra che spazzò via dalle strade d’Italia un’intera generazione, senza alcuna distinzione di censo. Si moriva in tutti i modi: fatti a pezzi dalle mitragliatrici austriache, sopraffatti dalle ferite negli ospedaletti da campo, minati dalle infezioni».
I calciatori vanno alla guerra
Antimoderni fino al midollo, i giuocatori di Brizzi, portarono carne e ossa, e i ricordi scanditi dalla logica e dalla disciplina sportiva, al fronte dell’assurdo, «le baionette puntate in avanti nell’assalto ad occhi chiusi». E lì si ritrovarono tutti, e i verdetti cambiarono. Tornò premiato con medaglia d’argento l’ex moccioso tenente di fanteria Alessandro Rampini, morì sul Carso il capitano nerazzurro Virgilio Fossati; stesso tragico destino per il nobile ufficiale d’artiglieria Guido Della Valle, fondatore del Bologna, e il figlio d’osti Guido Alberti, popolare mezzala rossoblù. Si spense dopo un mese di agonia il coltissimo dottor James Richardson Spensley, colpito mentre soccorreva un ufficiale germanico sul fronte occidentale, padre di quel Genoa che aveva sfidato l’Internazionale bianconera del Duca degli Abruzzi il 6 gennaio 1898 – facendo del calcio in Italia una faccenda maledettamente seria –, e con lui gran parte della squadra del Grifone, della dirigenza e delle riserve. Brizzi fa così, come fosse sul Carso – «mentre i traccianti illuminavano il cielo, le mitragliatrici miagolavano a colpo sicuro, e i ragazzi della tua compagnia ti morivano a fianco» – usando le parole capaci di colmare di dignità umana un nome altrimenti solo cavato dalla storia.

Fa così in guerra, ma anche sul campo, dove, nella cronaca del primo derby della Madonnina, il 18 ottobre del 1908, Brizzi assegna il suo bel posto al diavolo Pierino Lana che «porta i capelli ondulati e non fosse per il suo evidente strabismo, sarebbe considerato un bell’uomo», al giovanissimo portiere nerazzurro Campelli «detto “Nasone” che porta già in testa il berrettino a righe dal quale non si separerà mai più, nemmeno quando sarà chiamato a difendere la porta della Nazionale», al diciottenne Carlo Payer, «capace che i Milanisti siano andati a fargli i complimenti, e senza nessuna ironia», e ancora una volta – come dopo aver letto In piedi sui pedali, dato alle stampe per Mondadori solo un anno fa – l’accostamento al grande Gianni Brera, che scriveva come viveva, è inevitabile.
Viva è la lingua di Brizzi, perché viva la sua Italia, che non è solo quella che si muove su e giù dalle Alpi alla Sicilia con tutta la sua bella mercanzia di arbitri, palloni più pesanti, scarpe più pesanti, pantaloni più pesanti, e giocatori che liberi dal regime della moviola e dei fermo immagine tirano in porta tutte le volte che è possibile. È l’Italia di studenti, bottegai, medici, imprenditori, contadini che nel momento in cui si trovano un pallone tra i piedi o una baionetta tra le mani diventano protagonisti della storia, eroi in via d’estinzione, in una patria «intrisa di retorica militaresca che non riserva ori, ma solo allori per le sue leve schierate in campo e al fronte. Il calcio di allora non era un gioco per signorine, ma nemmeno per calciatori milionari, dispensatori di daspo o tifosi cresciuti nel culto della pace e della moviola – per i quali un “idolo” è un giocatore impegnato nello spendere parte della sua vita, e della sua fortuna, nel sociale –. L’epoca del grande calcio è segnata dal ritorno di guelfi e i ghibellini, eroi locali, bandiere e capitani, che anche se pettinati alla maniera del XX secolo indossano i colori di appartenenza, difendono il valore e l’onore di una comunità. Neanche la Grande Guerra li avrebbe fermati, avrebbe fermato il football».
Certo, nemmeno il calcio li avrebbe messi d’accordo tutti. I moralizzatori del calcio di oggi dovrebbero ripassare cosa accadde sugli spalti di tutta Italia tra i tifosi delle arrembanti camicie nere e le masse sindacalizzate, o ad Aldo Milano, detto Milano III, fratello minore delle stelle della Pro Vercelli Giuseppe e di Felice Milano, morto crivellato dai colpi di una guardia socialista la notte del 7 gennaio 1921, o ancora il 7 giugno del 1925 quando, sul campo milanese di viale Lombardia, si giocò lo spareggio dello scudetto tra Genova e Bologna.
Ceffi e rivoltelle a bordo campo
Non piacevano all’arbitro, l’avvocato Mauro, quei ceffi assiepati a bordo campo, le rivoltelle in fondina appese alla cintura, e in breve si ritrovò «circondato da una turba minacciosissima di Bolognesi in camicia nera che spalleggiavano capitan Della Valle e lo accusavano di essersi fatto comprare dai Genoani: non l’aveva visto che il pallone era entrato in rete e ne era uscito attraverso uno squarcio? No, francamente non l’aveva visto – racconta Brizzi –. Combattuto tra l’abdicare al proprio ruolo di giudice imparziale e il mantenersi fermo sulle proprie posizioni, l’avvocato Mauro intravide, in preda al panico, una terza soluzione: fuggire. Bianco come un cencio, si lanciò di corsa verso gli spogliatoi, deciso a barricarsi all’interno, ma fu riacciuffato e trascinato daccapo al rettangolo di gioco».
La maledetta partita doveva proseguire. E come andrà a finire è sempre questione di storia “vivente”, scritta dal bravo Brizzi e animata da un mazzo di galantuomini e personcine di paese. Che quel giorno in cui un filosofo baffuto baciò un cavallo in piazza Carignano, a Torino, cominciarono a indossare i calzoncini e a dare inizio, in tutta Italia, al meraviglioso giuoco del calcio.



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!