
Evviva: imbavagliato Trump, «la disinformazione è crollata»

Il Washington Post esulta perché – la citazione è letterale ed è anche il titolo dell’articolo datato sabato 16 gennaio 2021 – «dopo che la scorsa settimana diversi social media hanno sospeso il presidente Trump e alcuni suoi alleati chiave, la disinformazione online sui brogli elettorali è crollata del 73 per cento».
Il quotidiano capofila del fronte mediatico ostile al presidente uscente fa ampio riferimento nel pezzo ai risultati di una ricerca di Zignal Labs, azienda di San Francisco specializzata in analisi web, dai quali emerge «il potere delle società tecnologiche di limitare le falsità che avvelenano il dibattito pubblico». Così la vedono i due autori dell’articolo del Washington Post, la «Silicon Valley correspondent» Elizabeth Dwoskin e il «technology reporter» Craig Timberg, che dai toni appaiono molto soddisfatti del risultato ottenuto. Invece dovrebbero essere preoccupati.
Secondo Zignal, scrivono i due, «la settimana dopo che Twitter ha messo al bando Trump, le conversazioni riguardanti i brogli elettorali sono calate da 2,5 milioni di citazioni a 688 mila su diversi social media». La ricerca infatti spiega come le «falsità» attraversino diverse piattaforme, «rafforzandosi e amplificandosi» a ogni passaggio. Perciò, per non sbagliare, Trump e tanti suoi sostenitori sono stati bannati non solo da Twitter, ma anche da Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch, Spotify, Shopify eccetera. La successiva strage di fake news, insiste il Washington Post, dimostrerebbe «come un’azione concertata contro la disinformazione possa fare la differenza».
GUERRA ALLE «FALSITÀ»
Certo, se si vuole limitarsi a vedere la censura incrociata di Trump e dei suoi sostenitori come un rimedio alla «disinformazione», c’è da rallegrarsi, come in effetti fanno i giornalisti del quotidiano liberal, e come fa anche Kate Starbird, «disinformation researcher» alla Università di Washington, citata nel loro articolo. Bisogna però essere parecchio accecati dalla faziosità politica per non vedere in tutto questo una inquietante conferma di quanto scritto provocatoriamente da Niall Ferguson per lo Spectator: in quanto a silenziamento e intimidazione della parte avversa, la manovra anti-Trump della Silicon Valley non è poi così diversa dal cosiddetto golpe di Capitol Hill, salvo il dettaglio che questo è fallito, mentre quella è riuscita perfettamente.
A proposito di intimidazione. Di quel 73 per cento di post e cinguettii in meno sui presunti brogli elettorali del 3 novembre, quanti sono «disinformazione» di cui ci siamo liberati e quanti invece casi di autocensura, legittime opinioni inghiottite da utenti spaventati dall’idea che basti toccare il tema per provocare una ritorsione di Twitter? È una domanda che dovrebbero porsi con qualche preoccupazione anche al Washington Post, giornale che nel 2017, proprio in polemica con Trump, aggiornò il proprio motto in “Democracy Dies in Darkness”, la democrazia muore nell’oscurità.
DA UN HASHTAG A TUTTA LA DESTRA
Non è finita. L’analisi di Zignal rivela che anche gli hashtag legati all’insurrezione del Campidoglio (#FightforTrump, #HoldTheLine, “March for Trump”) sono diminuiti addirittura del 95 per cento tra Facebook, Instagram, Twitter e altre piattaforme. Ma l’effetto dell’operazione è ancora più pervasivo di così. Scrive sempre il Washington Post:
«Media Matters for America, organizzazione di monitoraggio dei media con tendenze a sinistra, ha stimato che nei giorni successivi alla decisione di Facebook di sospendere temporaneamente il profilo di Trump è sostanziosamente crollato anche il numero di persone che cliccano e condividono contenuti da pagine Facebook di destra».
Attenzione, non sfugga la sottigliezza: è cominciata come una guerra alla «misinformation», finisce come una ritorsione contro le «pagine di destra» in generale. E così Twitter, Facebook e compagni social hanno stabilito «il principio che i nemici politici possono essere silenziati. Si badi bene, non i dittatori ma i nemici politici», ha fatto notare Pierluigi Battista, ormai ex commentatore del Corriere della Sera. Mentre Niall Ferguson osserva sgomento la «sbalorditiva dimostrazione di potere» dei colossi della tecnologia, la loro «supremazia» su uno spazio ormai riconosciuto da tutti come pubblico. Eppure al Washington Post la situazione sembra suscitare soltanto sollievo.
SOTTO A CHI TOCCA
Ma se oggi è toccato a Trump, domani chissà. Obiezione: Trump però twittava «falsità» sulle elezioni. Risposta: può darsi, ma sicuri di voler delegare a Mark Zuckerberg, Jack Dorsey e compagnia il compito di accusare, giudicare e punire i promotori di «falsità»? Non sono un segreto le loro simpatie politiche e culturali. E pare superfluo stare a declinare qui uno per uno i tantissimi argomenti scomodi o non allineati che un domani potrebbero essere banditi dalla piazza social (insieme ai loro autori) in quanto ritenuti «falsità» o, peggio, istigazione all’odio e alla violenza.
Tra parentesi, il Washington Post è da qualche anno proprietà di Jeff Bezos, il padrone di Amazon, un fatterello che rende questa crociata contro le bugie come minimo un po’ viscida. Scrivono i suoi due giornalisti di Bezos:
«Si dice che Trump stia cercando una nuova casa tra i social media – si sono fatti i nomi di Parler, Gab o Telegram, tutti e tre popolari tra gli utenti conservatori – ma a quanto pare non ne ha ancora scelta una. Parler è rimasta offline per la maggior parte della settimana ma starebbe tentando di riprendere l’operatività dopo che Google e Apple l’hanno rimossa dai loro app store per via della scarsa moderazione delle conversazioni violente. Amazon Web Services ha sospeso Parler, mettendola offline».
UN PREGIUDIZIO «MAI DIMOSTRATO»
Lo stesso boss di Twitter, Jack Dorsey, si è dispiaciuto – a parole – per aver «stabilito un precedente che avverto come un pericolo: il potere di un individuo o di un’impresa su una parte del dibattito pubblico globale».
Having to take these actions fragment the public conversation. They divide us. They limit the potential for clarification, redemption, and learning. And sets a precedent I feel is dangerous: the power an individual or corporation has over a part of the global public conversation.
— jack (@jack) January 14, 2021
Insomma, non c’è bisogno di trarre molte altre morali da questa brutta favola purtroppo reale. Basta leggere quel che scrive il Washington Post per restare sconcertati.
«Per anni Trump e i suoi alleati politici si sono scagliati contro quello che loro chiamano “Big Tech”, denunciando pregiudizi nei confronti delle voci conservatrici senza fornire prove sistematiche e spingendo le società a usare mano leggera nella moderazione dei contenuti e nella sanzione di chi violava le loro policy».
Qualcuno ha visto le prove di tali pregiudizi? Adesso, chissà, Big Tech si deciderà finalmente a far sparire anche quest’altra «falsità» mai dimostrata.
Foto Ansa
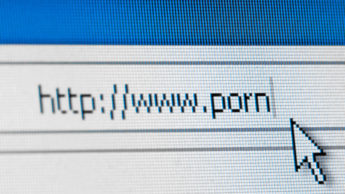


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!