
Il liberalismo ha fallito. Inizia l’epoca della libertà

Articolo tratto dal numero di agosto 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.
Finalmente viene tradotto in italiano Why Liberalism Failed, il libro scritto due anni fa da Patrick J. Deneen, professore di Scienze politiche e titolare della cattedra di Studi costituzionali del David A. Potenziani Memorial College presso l’Università di Notre Dame, nell’Indiana, e finalmente il suo autore partecipa a una conferenza pubblica in Italia, anche se soltanto da remoto in occasione del Meeting di Rimini. Nel mondo dei benefici dell’economia globalizzata e dei diritti per tutti, nel mondo della “fine della storia”, fino a qualche anno fa affermare che il liberalismo ha fallito sarebbe stato considerato una bestemmia, o una provocazione da parte di qualcuno degli ultimi autocrati rimasti. Ma dopo la serie di exploit elettorali populisti di destra e di sinistra degli ultimi anni nei paesi occidentali e l’ascesa geopolitica di sistemi politici autoritari/plebiscitari che vanno dalla Cina alla Russia alla Turchia e che sembrano essere presi ad esempio dai paesi emergenti, ogni analisi critica approfondita sull’inceppamento della marcia apparentemente inarrestabile della liberal-democrazia globalizzata viene accolta con interesse.
L’analisi di Deneen è impietosa e muove da una visione della civiltà e della politica che deve tutto alla tradizione delle virtù civiche greco-romane e giudaico-cristiane. Il liberalismo per Deneen è come l’uomo che ha segato il ramo sul quale era seduto e che è destinato a precipitare rovinosamente al suolo dopo avere per un certo tempo usufruito dei profitti della legna venduta. Il liberalismo ha prodotto benefici materiali e intellettuali grazie al fatto che poteva contare sul capitale di virtù civiche e di coesione sociale prodotti dalle civiltà precedenti, ma quando ha realizzato nella concretezza storica il suo ideale astratto di uomo autonomo e indipendente – e la cosa è successa negli ultimi cinquant’anni – il risultato è stato la disgregazione sociale, la degradazione dell’ambiente, la diseguaglianza crescente fra una classe ristretta di ricchissimi e una massa di popolo che rischia di restare priva di pensioni, assistenza sanitaria e posti di lavoro per figli e nipoti. Il liberalismo alla fine ha beneficiato una ristretta aristocrazia che si differenzia da quella dell’epoca feudale solo perché non è fondata sul sangue, ma sulla formazione ricevuta presso le università di élite. Tuttavia l’elemento dell’ereditarietà rientra per il fatto che solo chi è figlio di membri di questa aristocrazia della conoscenza può a sua volta accedere ai templi del sapere che riproducono un ordine sociale piramidale, dove in cima e alla base ci sono sempre gli stessi.

Deneen non pretende di pronosticare quale sarà l’esito del collasso dei sistemi liberali sul piano politico, ma indica la via di un’alternativa praticabile da subito: creare luoghi dove sia possibile trasmettere le virtù civiche fra le generazioni, creare esperienze di autogoverno sulla base di queste virtù là dove si è o là dove si decide di creare nuove comunità.
L’intervista che segue può valere da introduzione alla lettura del libro, che sarà disponibile in italiano dal 30 settembre.
Professor Deneen, lei parteciperà da remoto a una conferenza organizzata dal Meeting di Rimini sulla decrescente fiducia nei confronti della democrazia, ma lei è soprattutto noto per aver scritto il libro Perché il liberalismo ha fallito. È veramente così? Con tutti i suoi difetti, non è un sistema che fa venir voglia a chi ci vive di emigrare in Cina, in Russia o in Venezuela, per non parlare dell’Iran o del califfato dell’Isis.
La sintesi della tesi del mio libro è che il liberalismo ha fallito perché è pienamente riuscito. Il suo successo nasconde e allo stesso tempo rivela i suoi fallimenti. Come sistema politico, sociale ed economico, il liberalismo è diventato pienamente se stesso; questo significa che sotto la sua egemonia le persone si ritrovano ad essere allo stesso tempo radicalmente indipendenti e tuttavia schiave in un modo nuovo degli strumenti che avrebbero dovuto liberarle, compresi il sistema politico rappresentativo, l’economia globalizzata e la tecnologia. La differenza rispetto alla palese oppressione dei sistemi più apertamente autoritari è che i soggetti del sistema liberale non hanno riconosciuto la natura della loro condizione. Gli scontenti fra loro stanno sempre più facendo sentire la loro voce non emigrando in altri sistemi politici, ma mostrando il loro rigetto dell’ordine liberale dominante attraverso il loro voto a uomini e partiti antisistema.
Lei descrive l’élite progressista liberale come una nuova aristocrazia che ricorda lo status privilegiato degli aristocratici dell’ancien régime. Il liberalismo, secondo lei, è un sistema concepito a vantaggio dei privilegiati e a danno delle classi lavoratrici che ne risultano impoverite. Su quali basi formula un’accusa così grave?
L’evidenza dell’esistenza di una nuova “aristocrazia” liberale non è mai stata così forte. Oggi una piccola e autoreferenziale classe dirigente governa le istituzioni chiave della società liberale: la sua burocrazia, le sue istituzioni educative, i suoi media e la sua industria dell’intrattenimento, le sue principali istituzioni culturali. Essa possiede non soltanto la stragrande maggioranza della ricchezza del mondo occidentale avanzato, ma anche le sue principali forme di autorità e di status. Negli Stati Uniti questa classe dirigente è individuata e formata nelle università di élite, dove impara a mostrarsi esteriormente molto impegnata a favore dell’uguaglianza, nel mentre che viene sistematicamente addestrata e preparata a far parte dell’élite dirigente. Il fatto che ci si domandi se questa nuova aristocrazia esista davvero riflette il profondo livello di autoinganno della classe dominante, che ha convinto se stessa che non esiste una classe liberale dominante e che cerca di ingannare l’intera popolazione a questo riguardo.
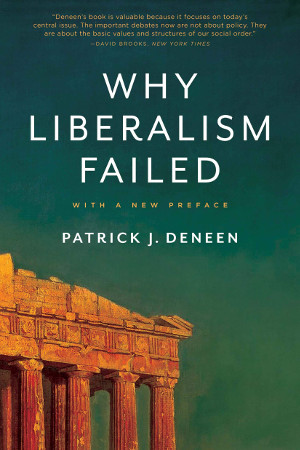
Lei sostiene non solo che il liberalismo ha fallito, ma che è sull’orlo del collasso. Che cosa finirà per abbatterlo definitivamente?
Come al tempo dell’ancien régime, è plausibile che l’ordine liberale possa continuare ad esistere per parecchio tempo dopo che la sua legittimità si è effettivamente esaurita. Si può affermare che abbiamo già raggiunto questo punto, col simultaneo rigetto da parte dell’elettorato dei partiti e delle leadership liberali di centrodestra e di centrosinistra negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in buona parte dell’Europa. Tuttavia le élite liberali continuano a controllare le posizioni chiave in importanti istituzioni e stanno lottando – e continueranno a lottare – ferocemente, e anche violentemente, per mantenere le loro posizioni. Al momento attuale lavorano a minare la legittimità dei leader “populisti” eletti, ma quando questa strategia avrà successo avrà l’effetto di approfondire l’insoddisfazione degli scontenti nell’elettorato, e di spingerli nelle braccia di oppositori potenzialmente più estremi rispetto all’ordine liberale.
Che cosa verrà dopo il collasso del liberalismo che abbiamo conosciuto? Un “dispotismo liberalocratico”, secondo l’espressione che lei utilizza nel libro? O un nazionalismo autoritario?
Naturalmente non possiamo saperlo. La storia non è già scritta, e non è facile fare previsioni in tempi turbolenti. Il mio pronostico è che i particolari esiti politici saranno specifici per ciascuna nazione, e mescolati con una sana dose di contingenza. Uno degli esiti che già vediamo è la varietà di populismo politico-teologico che è sorto in nazioni con forti tradizioni nazionaliste e religiose come l’Ungheria e la Polonia. Nel Regno Unito una miscela di approcci politici sia laburisti che conservatori può dare vita a qualcosa come un “partito conservatore rosso”, che combinerebbe forme di un’economia più sociale con valori sociali più conservatori al fine di produrre più stabilità per le classi lavoratrici. Questa sembra essere anche la traiettoria del Partito repubblicano negli Stati Uniti, con l’aggiunta di un elemento di fortissima avversione alla Cina e di profondo sospetto nei confronti delle tendenze monopolistiche delle industrie tecnologiche dominanti. Naturalmente se l’economia mondiale dovesse sprofondare in una grave crisi potrebbero manifestarsi forme piuttosto maligne di autoritarismo postliberale, oppure riaffermazioni di un liberalismo illiberale, cioè appunto un “autoritarismo liberalocratico”. Non credo che ci sarà un solo esito, ma molte diverse espressioni di visioni del mondo postliberali.
Come contributo alla questione di come affrontare l’era postliberale, lei propone «comunità alternative e nuove culture che vivranno all’esterno del cumulo di macerie degli anni del tramonto del liberalismo», «forme di autogoverno che sorgano da una partecipazione civica condivisa». Non è utopico? A parte gruppi marginali come gli Amish, molte poche persone sembrano impegnate in questo genere di esperimenti al momento presente.
Queste raccomandazioni – costruire comunità resilienti specialmente di famiglie riunite comunitariamente, insegnare un insieme di valori molto differente dall’individualismo e dal materialismo dominanti dell’ordine liberale – sono un consiglio per persone che vogliono agire ora, senza aspettare necessariamente un cambiamento complessivo dell’ordine politico. È una raccomandazione che vuole essere esattamente l’opposto di un approccio utopistico, se per utopia intendiamo un cambiamento globale del sistema. Si tratta piuttosto di un incoraggiamento rivolto alle persone perché comincino semplicemente a vivere e ad agire in un modo diverso ora, subito, nel posto dove si trovano o in luoghi dove possano ritrovarsi con persone simili a loro. È una cosa che sta accadendo già da qualche anno negli Stati Uniti – specialmente fra persone con una forte fede religiosa – e che mi sembra proprio l’opposto di qualcosa di utopico. Premesso questo, direi che si tratta probabilmente di cose non tanto utopistiche, quando si considera che una forma sempre più autoritaria di liberalismo illiberale si rifiuta di permettere a questo genere di comunità di esistere. Vediamo questo, per fare un solo esempio, nel rifiuto di paesi come la Germania di permettere alle famiglie di impartire ai figli l’educazione parentale (homeschooling, ndt). A causa di ciò si rende necessario anche un approccio più “utopistico”, più direttamente politico, anche se per questo ci vorrà più tempo e il successo sarà più incerto.
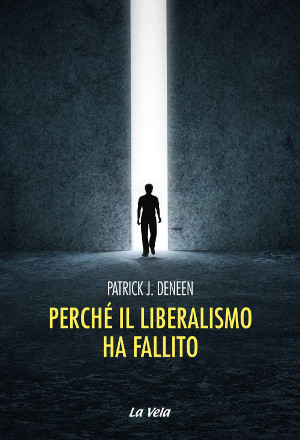
È interessante il fatto che lei attribuisca un valore politico al lavoro e alle abilità manuali, che dovrebbero essere insegnati alle giovani generazioni come una componente dell’educazione alle virtù civiche. Che cosa intende esattamente?
La classe dominante liberale vive un crescente divorzio dalla realtà del mondo. Costoro non fanno e non costruiscono; in molti casi non hanno figli e non accompagnano i loro genitori nella vecchiaia fino alla morte; si spostano di frequente e non capiscono la natura del vivere radicati e in una comunità di vecchia data. Credo che un antidoto alla radicale irrealtà, sconfinante nello gnosticismo, dell’umanità liberale richieda la reintroduzione alla realtà nella forma del lavoro con la materia di cui sono fatte la realtà e la natura. In questo modo potrà imparare le possibilità naturali e i limiti delle cose del mondo, potrà reimparare che l’essenza della cultura è la combinazione delle abilità umane coi fenomeni naturali, e apprendere l’orgoglio di cominciare e completare un progetto che ha un inizio e un compimento ben definiti.
Lei è un intellettuale cattolico. Esiste un pensiero politico cattolico oggi? Pensa che sia necessario che ne esista uno?
Abbiamo troppo pochi intellettuali cattolici che siano stati immersi nella tradizione intellettuale cattolica: la sua filosofia, la sua arte, la sua teologia, la sua letteratura, le sue più profonde convinzioni intorno all’antropologia dell’essere umano e alla natura sacramentale dell’ordine creaturale. Una precedente generazione di cattolici è venuta meno alla sua responsabilità di trasmettere queste lezioni vitali, perciò, osservando le macerie della cosiddetta cultura cosiddetta secolare, oggi i più giovani hanno dovuto apprendere queste lezioni e queste idee più antiche non come una conseguenza di un naturale processo di trasmissione ereditaria, ma attraverso una specie di ricostruzione di un mondo perduto. Ci sono una tremenda energia ed eccitazione intellettuali specialmente fra gli intellettuali cattolici più giovani (molti dei quali si trovano negli Stati Uniti, ma io ne ho incontrato un numero crescente in giro per l’Europa), che sono nello stesso tempo arrabbiati per essere stati privati di questa eredità, ma determinati tuttavia a farla propria. Abbiamo disperatamente bisogno di questa generosa messe in questa arida epoca che considera gli umani semplicemente come un tipo di animale, come un fascio di appetiti che vivono una vita senza significato tranne le distrazioni che possono essere assemblate. Una visione alternativa incentrata sull’amore, la famiglia, la fede, la comunità e la continuazione di una lunga tradizione di memoria e di gratitudine nei confronti di ciò che è dato rimane un’eterna possibilità e il più grande dono per questa epoca.
***
Al Meeting Patrick Deneen dibatterà con Luciano Violante, ex presidente Camera, all’incontro dal titolo “Democrazia e fiducia: un nesso da riscoprire”. Modera il costituzionalista Andrea Simoncini. Appuntamento previsto per mercoledì 19 agosto ore 15.
Per leggere gli altri articoli dello Speciale Meeting contenuto nel numero di Tempi di agosto, clicca qui
Foto Ansa



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!