
Il mio ricordo di un altro grande politico «purificato» da un processo ignobile

Articolo tratto dal numero di Tempi di marzo 2019.
Noi molokani arriviamo sempre, secondo il vostro concetto, troppo tardi. Ma tardi rispetto a che? All’eterno? Per questo me ne impipo delle regolette sui centenari che vanno celebrati prima del tempo perché altrimenti scadono. A noi, per posta, ma temo non aerea, è arrivato un malloppo con le riproduzioni della mostra fotografica su Giulio Andreotti a Roma, in San Salvatore in Lauro. C’è tutta la vita, e si vede che l’anima di Andreotti è una sola. Quando appare circondato da Livia e dai suoi figli, e quando è ritratto con i grandi della terra, i capi di Stato e i romani pontefici; oppure quando è solo. In quest’uomo sono una sola cosa il volto e la vita, gli incontri personali e la sua visione del mondo, il suo essere un popolano e uno statista. La famiglia e i summit. I capelli scompigliati dal vento in mare, e quando gli stanno ordinatamente incollati al Senato.
Non era un essere finto, ironico fuori e cupo dentro, con caverne tenebrose dove coltivava una morale detta ragion di Stato. Non è mai esistita nelle pieghe della sua coscienza l’ammissibilità di un doppio standard etico. Uno da padre e marito, l’altro da statista. In nessun istante della sua vita pubblica ha mai lasciato campo a teorizzazioni secondo cui si possa vivere secondo princìpi segretamente autorizzati alle cosiddette élite di governo. Se lo fai, ti danni. Nei frequenti incontri privati che con lui ho avuto mai e poi mai ha alluso ad azioni dove fosse contemplata l’autorizzazione a contravvenire anche a un risvolto minimo di uno solo dei dieci comandamenti. Questa è la mia testimonianza e la vedo perfettamente riflessa nelle fotografie.
Ha raccontato di sé e del suo rapporto con la fede, l’ho interrogato in pubblico al Meeting di Rimini. Era sottoposto a pressioni tremende, durante i processi calunniosi, ha retto, ma non per eroismo ma sostenuto dalla grazia e dai fratelli cristiani. Specie da papa Giovanni Paolo II che mai si vergognò di lui. Mentre infuriava la tempesta, e pareva sicuro che l’antico leader della Fuci fosse inchiodato a una condanna come mandante dell’agguato assassino contro il giornalista Pecorelli (era stato giudicato colpevole a Perugia: più di vent’anni in secondo grado!) e un cattolico progressista in veste di procuratore come Gian Carlo Caselli lo illustrava come complice del male assoluto della mafia. Ecco mentre questo vento gelido lo dipingeva come Belzebù incarnato, papa Wojtyla lo benedisse, credette in lui, si fidò. Confessò: «Non ho mai attraversato il buio della fede.
Ho letto di certe notti tremende in alcune pagine di Madre Teresa di Calcutta e di Padre Pio. Io non ne ho avute, e devo per questo gratitudine a Dio. Ho sempre sentito una certa protezione. Sono un cattolico romano. Questo comporta grandissime responsabilità, però porta anche delle certezze. Come questo nel conto finale servirà non so. Ma ognuno di noi deve fare più affidamento sulla misericordia di Dio che sul proprio libretto di lavoro, almeno io penso così». E il processo, come entra in questo conto? È stata una purificazione. «Ero abituato a troppi onori e tappeti rossi. Non arrivo a ringraziare chi mi ha teso la trappola, ma non porto rancori». Disse ancora: «Io penso che non mi hanno fatto male».
La stima di Benedetto XVI
Non sono riusciti a fargli del male, neppure quelli che cercano di sfregiare il suo centenario. Anche se ci provano ancora.
Di lui ha scritto alcuni mesi fa Benedetto XVI: «L’ho incontrato solo di rado, in verità, tuttavia mi spediva regolarmente a casa piccoli biglietti nei quali era spesso contenuta una frase che mi rimaneva impressa, e per Natale mi faceva sempre regali particolarmente ricercati. Di lui ho ammirato due cose. La ricchezza di humor con cui sapeva alleggerire lo scenario politico, e soprattutto la forza d’animo di cui diede prova nei lunghi anni in cui, nel processo sulla sua presunta appartenenza alla mafia, subì oltraggi pubblici mostruosi e fu profondamente ferito nel suo onore e nella sua dignità. Solo un uomo di grande forza interiore poteva superare quegli anni senza cadere nell’amarezza ed essere distrutto dentro».
Dedico queste righe molokane a Roberto Formigoni. Anzi si può dire che Andreotti è stato un pretesto per scrivere a Formigoni. Fratelli, nella buona e nella cattiva sorte, gareggiando in stima vicendevole.
Foto Ansa
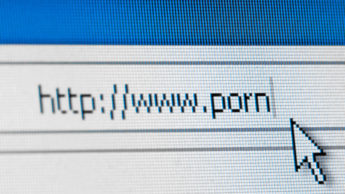


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!