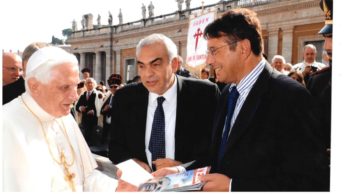
La «certezza» da cui nasce una scuola

Egregio direttore, il “duetto Villa-Boffi” fa il paio con “il giornale fionda”: due simpaticissime immagini per avviare un discorso serissimo senza inutili animosità e finalmente dotato di ragioni e non impastato di ideologie. La pregherei soltanto di “silenziare un poco” la vicenda di Tarcento proprio per lasciarla alle sue reali dimensioni che sono il suo piccolo valore. Mi spiego brevemente: la scuola è nata da un cedimento “sentimentale” alla implorazione di un gruppo di mamme che nel settembre del 1976 non hanno accettato l’esodo proposto da Giuseppe Zamberletti (sottosegretario agli Interni, commissario straordinario per il terremoto in Friuli, ndr) e ci hanno implorato di non abbandonarle, restando a fare scuola. I cinque miei amici che le ascoltavano, invece di aiutarmi a persuaderle della impossibilità di rimanere, davanti a loro dissero: «Villa, perché no?». Il mio rifiuto si basava su semplici constatazioni: primo, la mia totale inesperienza; secondo, la totale mancanza di logistica (avevamo un tendone, un box e un po’ di tende). Sapete con quali argomenti mi contrastavano? Primo, che siamo capaci di imparare; secondo, che non avere niente in quella situazione era stimolante; terzo, che il nostro don Giussani ha fatto dell’educazione una vetta da raggiungere. Morale della favola: non si può in nessun modo parlare di “fondazione”. Per decidere di fare una scuola l’unica condizione è che si sia ben chiara nel cervello la certezza del suo valore e nel cuore l’adesione alla logica del Vangelo: “Vuoi fare una torre, fai bene i calcoli”, altrimenti… viene il Gabibbo.
P.s. La parola “gratuità” non va bene. La scuola ha un costo, come i figli a casa che però non pagano le rette. Trovare i soldi è anche questione di ingegno: se si può, perché no? Saluti.
Don Antonio Villa – Tarcento
Ringrazio don Villa per questa ulteriore lettera perché aiuta (in primis il sottoscritto) a centrare meglio la questione che è, io credo, quella di capire bene cosa sia questa «certezza nel cervello» e questa «adesione nel cuore» di cui lui parla. A questo proposito, ieri abbiamo ricevuto quest’altra email che di seguito riproduciamo.
* * *
Caro direttore, a proposito del dialogo iniziato su Tempi a proposito di scuola vorrei proporre alcune osservazioni. È diffusa oggi la convinzione che la L. 62/2000 – quella che ha realizzato la cosiddetta parità scolastica – sia una pietra miliare nel cammino verso la libertà di educazione, mentre è stata l’inizio della fine. Anzi, a guardar ancora più in profondità, la legge 62/2000 è stato l’atto giuridico che ha formalizzato e cristallizzato in dottrina statale un processo di progressiva rinuncia del popolo cristiano alla propria capacità di generare opere educative innanzitutto con la forza della propria fede, senza poggiare necessariamente su riconoscimenti e sovvenzionamenti da parte di uno Stato sempre più anticristiano. Mesi fa, se non ricordo male, Tempi pubblicò un articolo in cui si affermava che con la legge Berlinguer la questione della parità scolastica era diventata roba per specialisti, e che per questo, oggi, i più non sanno nemmeno di cosa si stia parlando. Così è.
Mi permetto allora di andare ancore oltre – probabilmente scandalizzerò tanti – ma lo voglio fare innanzitutto per smuovere la melma nella quale ormai sembriamo nuotare allegramente, quasi fosse una piscina olimpionica, sperando così di avviare un dibattito franco e costruttivo. E oso affermare che la grande e indimenticabile manifestazione di piazza San Pietro del 30 ottobre 1999, quella in cui si levò alto da decine di migliaia di partecipanti il grido «libertà libertà!», fu probabilmente fraintesa e mal interpretata, innanzitutto da chi poi tentò di raccoglierne i frutti. Non era questa la libertà che si voleva, e che in effetti non è arrivata… Non era, né doveva essere, la richiesta di una graziosa concessione da parte dello Stato-padrone, ma la gridata esplicitazione di una caratteristica indomita e guerriera della esperienza cristiana. Noi siamo liberi perché già liberati, e dunque dobbiamo vogliamo e possiamo realizzare scuole e opere educative innanzitutto per la forza della fede di alcuni e di un popolo che la condivide e li sostiene. Se poi lo Stato lo riconosce, tanto meglio. Ma non è a questo che si deve tendere in primis.
Viceversa, assistiamo alla progressiva, mortificante trasformazione di tante scuole paritarie in succursali cattoliche della dottrina pedagogica statale, tanto inavvertitamente quanto inesorabilmente inghiottite dalle “educazioni” finanziarie, economiche, ambientali, alla cittadinanza, alla parità di genere, alla sostenibilità, all’affettività, e chi più ne ha più ne metta… Una débâcle educativa che si accompagna, tra l’altro, alla necessità di mendicare continuamente dallo Stato le risorse per sopravvivere. Siamo sicuri che fosse proprio questo che si stava chiedendo col grido «libertà libertà!»?
Sarebbe bello poter ricominciare a parlarne serenamente, senza vicendevoli scomuniche, solo per il gusto – e il bisogno – di favorire l’estendersi e il moltiplicarsi di esperienze come quelle della scuola Monsignor Camillo di Gaspero. Vogliamo parlarne?
Alfredo Margotti via email
Caro Alfredo, sono andato a rileggermi il discorso che Giovanni Paolo II pronunciò quel 30 ottobre 1999 in piazza San Pietro a Roma. Il Papa parlò di «passione educativa» e, già ormai ventuno anni fa, individuò tutta una serie di problemi che ancora oggi noi constatiamo. Disse che ancora si attendeva un «pieno riconoscimento della parità giuridica ed economica tra scuole statali e non statali, superando antiche resistenze estranee ai valori di fondo della tradizione culturale europea. I passi recentemente compiuti in questa direzione, pur apprezzabili per alcuni aspetti, restano purtroppo insufficienti». E disse anche che occorreva continuare a chiedere «con forza ai responsabili politici e istituzionali che sia rispettato concretamente il diritto delle famiglie e dei giovani ad una piena libertà di scelta educativa». Sono tutti aspetti che occorre continuare a sottolineare, in particolare quest’ultimo, come ha fatto anche Peppino Zola nella sua lettera, che ci ricorda che l’educazione di un ragazzo è in capo alla famiglia, non allo Stato.
Il pontefice non si limitò a richiamare tutto questo, ma volle ricordare a coloro che “facevano” le scuole paritarie quale fosse lo scopo del loro sforzo. Richiamò il fatto che deve esserci «solidarietà e la simpatia di tutta la comunità ecclesiale, dalle diocesi alle parrocchie, dagli istituti religiosi alle associazioni ed ai movimenti laicali», parlò di «comunità educante», di «competenza e dedizione dei suoi insegnanti». È quello che noi abbiamo chiamato “popolo” ed esistono tanti esempi in giro per l’Italia di scuole paritarie sostenute da questa passione educativa.
Torniamo a quel 30 ottobre. Giovanni Paolo II rivolse a tutti i presenti questa richiesta: «Vi chiedo di dare sempre un’anima al vostro impegno, sostenuti dalla certezza che attraverso di esso partecipate in modo speciale alla missione che Cristo ha affidato ai suoi discepoli». Eccoci al punto: questa è la missione e la vocazione di una scuola paritaria (quello che noi definivamo col termine “ideale”) che noi non vorremmo fosse data per scontata. È la «certezza» di cui parlano sia il Papa santo sia don Villa (e non mi pare un caso che usino lo stesso termine). Parliamone.
Foto Ansa
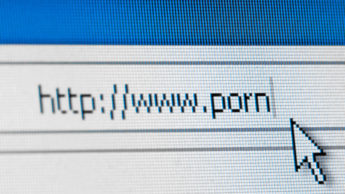


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!