
Ma è meglio la prosa o la poesia? Una disputa infinita
Il rapporto tra narrativa e poesia è molto complesso o, se si vuole, vivacemente dialettico, in continua ridefinizione come quello tra due coniugi di vecchia data. Ovviamente ci sono delle tifoserie agguerrite, chi sostiene la superiorità della scrittura in versi, come avviene generalmente fino al secolo diciannovesimo, e chi sostiene la superiorità della scrittura in prosa, come fanno alcuni romanzieri spericolati, tra i quali Gombrowicz, autore di un vero e proprio bando intitolato Contro i poeti, nel quale si scaglia contro i concetti di esclusività e stile, che in realtà sono applicabili tanto alla poesia quanto alla prosa.
Come accade nello sport, però, ci sono anche spettatori con un approccio più teoretico alla materia, per i quali non è tanto importante stabilire un primato, ma i termini della relazione, cioè, in quale rapporto reciproco stiano poesia e prosa, se di contiguità, quando non di coincidenza, o di lontananza. Per alcuni, per rimanere nella metafora sportiva, si tratta di specialità diverse della medesima disciplina, per altri di sport completamente differenti, che richiedono differenti capacità. Infine, c’è chi con un moto di insofferenza per le capziosità dei pedanti sostiene che siano “praticamente” la stessa cosa. A dar ragione ai primi ci sono moltissimi autori che si cimentarono in entrambe le “specialità”. Non c’è romanziere, per quanto programmaticamente sliricato, che non nasconda un passato di abbandoni miserevolmente autoindulgenti alla poesia. Secondo Kundera, che sull’argomento scrisse un bellissimo romanzo intitolato La vita è altrove e rientra, con le sue poesie giovanili, a pieno titolo nella succitata categoria, esiste una relazione causale tra giovinezza e spirito lirico, mentre il romanzo sarebbe il dubbioso approdo della maturità. Se a confermare la sua teoria interviene la sua esperienza personale, che lo vede trasbordare dalla poesia al romanzo nella sua variante comica, che, per Kundera, costituisce la sua unica vera vocazione, ci sono a smentirla i casi di molti poeti, che danno segno di aver tempestivamente soppresso il fanciullino pascoliano albergante in loro e che non scrivono poesia in un più o meno stanco protrarsi di furori giovanili, ma con pacatezza e ponderazione e non necessariamente sono gli agelasti comandati a bacchetta da Euterpe, che vorrebbe il romanziere ceco.
Tra i più eminenti romanzieri che si dedicarono anche alla versificazione si annoverano, per esempio, Proust e Nabokov, due autori, la cui prosa inclina spessissimo alla poesia. Ecco che, però, i fautori della seconda tesi si precipitano a impugnare le argomentazioni degli avversari e ribattono: “Sì, ma con quali esiti?”. In effetti il successo ottenuto dalle garbate poesie d’occasione di Proust, che risentono dell’invasiva influenza di Mallarmé, o dalla pur meravigliosa raccolta Poems and Problems di Nabokov fu assai limitato e non decisivo delle sorti dell’arte poetica in generale, come lo furono le loro opere in prosa dell’arte del romanzo.
A questo punto, si può fare un rilievo interessante, partendo da un curioso intervento giornalistico di Montale, il quale esortava i romanzieri suoi contemporanei a essere più fedeli al proprio decalogo, in una parola a essere più “prosaici”. Sembra piuttosto frequente che i romanzieri e i poeti abbiano idee molto tradizionaliste, un po’ talebane su quella che, senza precauzioni e in barba ai ragionamenti fin qui fatti, potremmo definire arte gemella: mentre nel proprio campo si arrogano la più grande libertà e sperimentano soluzioni felicemente spurie, nel campo a esso gemellato si comportano da veri puristi. È così che Nabokov guarda di cattivo occhio la poesia che si affranchi dalle pastoie secolari della rima e del metro, o che, giusto per fare un altro nome, Caproni nelle sue prose, raccolte e pubblicate da Garzanti, si discosta dagli squisiti valori formali della sua produzione in versi, così attenta al dato musicale, per riconvertirli in una prosa disadorna e leggermente atona.
Ci sono, poi, a sostegno della seconda tesi, romanzieri e poeti mancati: nessuno leggerà il grande romanzo che Baudelaire meditava di scrivere, e forse la fama di Bolaño sarà affidata alle sue straripanti affabulazioni piuttosto che alla sua opera poetica.
Restano da analizzare le forme intermedie come la poesia in prosa o il racconto, che parlano tutte di una sostanziale affinità tra i due generi.
Si potrebbe concludere con la Gaia scienza di Nietzsche che non si scrive buona prosa se non sotto gli occhi della poesia e, potremmo aggiungere, viceversa, con la consapevolezza che si tratta di una guerra incessante, che prevede, però, attimi di sublime riconciliazione.
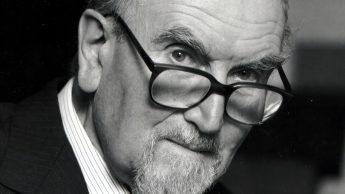


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!