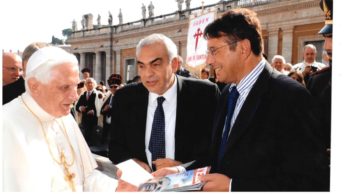
Meeting Rimini 2012. L’anima del popolo russo
Nel 1993 al Meeting di Rimini era stato invitato il Coro dell’Armata Rossa, un imponente corpo musicale che aveva eseguito uno splendido concerto (pressoché lo stesso repertorio offerto nel 2004 a Giovanni Paolo II, per il suo compleanno, in una memorabile serata in Aula Nervi) di canti popolari russi, dove figuravano anche alcuni pezzi di musica liturgica, che il coro eseguiva però senza parole, a bocca chiusa, secondo l’uso, invalso in epoca sovietica, della separazione tra Stato e Chiesa e tra Chiesa e società.
A distanza di quasi vent’anni, uno degli eventi del prossimo Meeting sarà, mercoledì 22 agosto, un grande concerto eseguito dal Coro dei sacerdoti della diocesi di San Pietroburgo (anch’esso molto famoso in Russia), che pure proporranno un repertorio di canti sacri e della tradizione popolare russa.
Nonostante le evidenti differenze tra i due eventi, vale la pena di sottolineare la continuità per cui la tradizione musicale sacra e popolare del popolo russo è rimasta un punto di riferimento persino per le generazioni nate e cresciute sotto il comunismo. Di più, in epoca sovietica i canti popolari e le canzoni dei soldati sono spesso divenuti – insieme alla poesia – espressione di una religiosità e di domande ultime a cui era vietato dar voce nelle forme tradizionali. Ad esempio, la canzone “Le gru” (1969), che ascolteremo nell’esecuzione del coro pietroburghese, rievoca i caduti della Seconda Guerra Mondiale, «che, forse si son trasformati in bianche gru,/ e da quei giorni, ormai lontani,/ volando, ci lasciano un’eco delle loro voci./ Forse per questo, con tanta nostalgia noi spesso/ leviamo gli occhi, in silenzio, al cielo?/ …/ Vola, vola nel cielo lo sciame estenuato/ vola nella nebbia sul calar del giorno./ E vedo nello sciame un posto vuoto,/ forse quel posto è destinato a me…».
Suppliche e ringraziamenti
Se questo è stato il ruolo della musica popolare, espressione di un “io” comunitario in cui la persona si riscopre in maniera autentica attraverso la compassione e la responsabilità per le sorti della propria gente, della propria terra ma più in generale dell’universo intero, la stessa cosa vale a maggior ragione per la musica sacra, che nella tradizione del cristianesimo orientale e russo in particolare ha sempre occupato un posto privilegiato.
La musica sacra, infatti, è molto di più di un armonioso accompagnamento della celebrazione liturgica, che – come avviene invece in Occidente – solennizza ma non aggiunge niente al Mistero divino che vi si celebra: il canto sacro (poiché l’unico strumento degno di cantare le lodi di Dio è la voce umana, e quindi la liturgia non prevede l’uso di musica strumentale) è parte integrante della liturgia, esprime la supplica o il rendimento di grazie che i fedeli innalzano a Dio seguendo l’esortazione del sacerdote e del diacono. Del resto, nell’acuta percezione che la tradizione della Chiesa d’Oriente ha della presenza del Mistero, vero protagonista dell’azione liturgica, l’uomo non può rivolgersi a Dio parlando come farebbe nella dimensione quotidiana, feriale: in questa sfera c’è posto solo per il canto e la salmodia, a sottolineare in ogni aspetto del rito la bellezza, la trasfigurazione della vita umana e dell’universo, di cui la liturgia è anticipo. Infine, nella liturgia, che nei secoli è stata lo strumento educativo per eccellenza del popolo russo, non c’è spazio per il vacuo parlare umano: le preghiere e gli inni sacri di cui essa è intessuta costituiscono un distillato dei testi più ricchi e pregnanti della Tradizione (la Scrittura, i Padri della Chiesa), esprimono il dialogo d’amore tra il Creatore e la sua creatura, e lo stupore e l’esultanza dell’uomo al cospetto del Mistero che crea e sostiene l’essere in ogni istante del tempo.
I fedeli non sono spettatori passivi
Il concerto del 22 agosto ha in repertorio alcuni dei pezzi più belli della liturgia bizantina, tra cui, in particolare, vari brani del ciclo pasquale, che piange Cristo «addormentato nella carne» esultando nel contempo nell’albore della Resurrezione. Il mistero della morte e resurrezione ritorna anche in uno splendido inno (kontakion), che si canta nella festa della Dormizione della Vergine Maria: «La morte e il sepolcro non prevalsero sulla Madre di Dio che prega senza requie. Alla vita infatti è stata trasferita la Madre della stessa Vita…». Ancora, risuonerà il possente inno “Dio è con noi”, che si canta nella festa di Natale, quando – di fronte a un inerme bambino adagiato in una mangiatoia – la Chiesa ha il coraggio di sfidare i potenti di questo mondo e ripete esultante, vittoriosa, le parole di Isaia (9,5): «Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace».
Il Coro dei sacerdoti di San Pietroburgo eseguirà inoltre alcuni brani dei celebri Vespri di Sergej Rachmaninov (“Venite adoriamo il nostro Dio”, “Ave Maria”, il Tropario pasquale “Risorgendo da morte…”), un’opera drammatica, eseguita per la prima volta a Mosca nel 1915, in cui si fondono tradizione e pietà per l’umanità contemporanea, travagliata dai conflitti bellici che di lì a poco sarebbero sfociati nella rivoluzione.
La serata proposta dal Coro dei sacerdoti di San Pietroburgo non è però un semplice concerto: vuol essere una testimonianza di fede, anzi un’«epifania della bellezza della Chiesa», come amano ripetere i cantori, che hanno realizzato nel corso di questi anni un’esperienza realmente straordinaria di fraternità e di missione attraverso il canto, immagini e brevi testi di commento.
Se il Coro dell’Armata Rossa, sorto nel 1945, è stato per decenni una sorta di biglietto da visita della cultura sovietica, i cori sacri – legati perlopiù a monasteri, seminari e accademie teologiche – hanno avuto il diritto di esibirsi ufficialmente solo all’indomani della caduta dei muri, alla fine degli anni Ottanta. Ma sovente si assiste anche al fenomeno opposto: vale a dire, diocesi e parrocchie facevano e fanno tutt’oggi ricorso a cori o a singoli cantori “professionisti” per le celebrazioni liturgiche, sia perché cantare stabilmente nel coro risulta un impegno troppo gravoso per i fedeli, sia perché si desidera un alto livello di esecuzione musicale. Un fatto, questo, che rischia a volte di trasformare la liturgia in spettacolo, e i fedeli in spettatori passivi di un gesto in cui il loro coinvolgimento si riduce all’ascolto.
Il Coro dei sacerdoti di San Pietroburgo segna realmente una nuova possibilità di cammino, iniziato nel 1971 (in piena epoca sovietica), grazie a una geniale intuizione del metropolita Nikodim Rotov – una delle figure più complesse e interessanti del suo tempo (sarebbe morto, fulminato da un infarto, tra le braccia di papa Giovanni Paolo I, nel 1978): la possibilità di unire la bellezza del canto, la testimonianza resa a Dio attraverso la preghiera cantata e un’attenzione educativa nei confronti dei fedeli.
Il coro, composto di 40 elementi, ha quindi alle spalle una lunga storia, che passa attraverso la stagnazione sovietica e la rinascita della Chiesa ortodossa russa nel 1988, anno in cui si celebrò il Millennio del Battesimo della Rus’. All’improvviso, caduti gli impedimenti esteriori e svelatasi agli occhi di milioni di persone la menzogna dell’ideologia, il sacro faceva irruzione nella vita sociale, e il Coro sacerdotale è stato chiamato a eseguire concerti nelle sale più belle del paese. Da quel momento, è rimasto nella vita della Chiesa e della Russia come un potente richiamo alla bellezza che si fa preghiera.
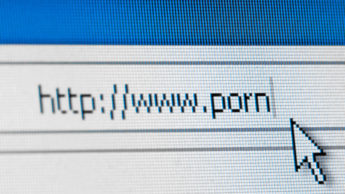


1 commento
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!