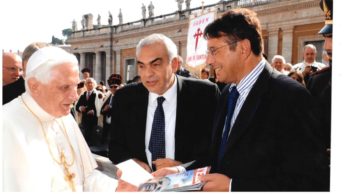
Nubile, pagata a cottimo e pronta alla frusta. La prof ideale secondo don Milani (altro che mobilità)

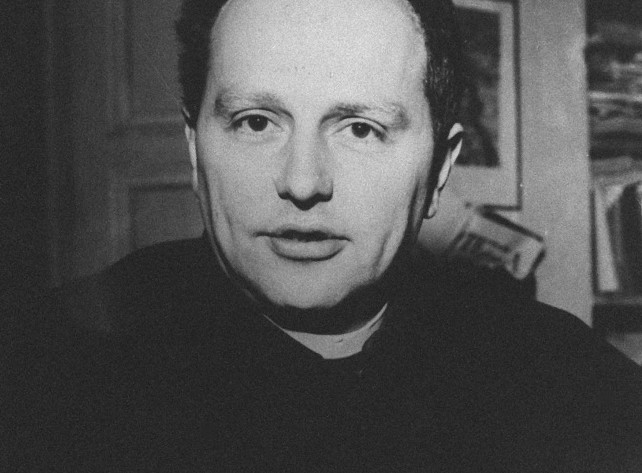
«Si può dissentire da alcune rigidità e integralismi presenti in don Milani ma il peggior tradimento sarebbe fare di lui un santino, approvato da tutti a parole con grande ipocrisia. L’unica accusa che proprio non si può fare è attribuirgli una surreale postuma paternità di una scuola facile e permissiva, che non boccia e non si cura dell’istruzione dei ragazzi». Così il maestro delle elementari ed educatore Franco Lorenzoni nel suo intervento sulla Domenica del Sole 24 Ore del 5 marzo scorso, che fa seguito a un dibattito aperto da un articolo del filologo Lorenzo Tomasin sul quotidiano della Confindustria in merito all’eredità del prete di Barbiana.
Per Milani nella scuola dell’obbligo l’insegnante non doveva bocciare (ma solo fino alla terza media e non, quindi, anche all’esame di licenza, come scrive nella Lettera a una professoressa: «Nella scuola dell’obbligo, l’obbligo l’avrebbe assolto portando tutti alla terza. È all’esame di licenza che può sfogare i suoi istinti di selezionatrice. Non avremmo più nulla da ridire. Anzi, se il ragazzo non sa ancora scrivere farà bene a bocciarlo»; all’università poi la «selezione» era «doverosa»).
Bocciare voleva dire infatti non solo respingere i più poveri «nei campi e nelle fabbriche» ma anche impoverire quelli che gli studi proseguivano. Negare ai primi, espellendoli dalla scuola dell’obbligo, la possibilità di «possedere la parola» non poteva non privare loro del «mezzo d’espressione» e i ricchi della «conoscenza delle cose».
Ma per fare dell’alunno, attraverso la padronanza della parola, un individuo consapevole e non indifeso di fronte ai tentativi di menomazione e aggressione dei propri diritti, che tipo di insegnante disegnava Milani nella sua Lettera? Un tipo assolutamente incompatibile con la proposta democratico-progressista, di ieri come di oggi (più in generale, indubbia era la diffidenza di Milani nei confronti di quel mondo: «Ci ho messo venticinque anni a uscire dalla classe sociale che scrive e legge l’Espresso e Il Mondo. Non mi devo far ricattare nemmeno per un solo giorno. Mi devono snobbare, dire che sono un ingenuo e un demagogo, non mi devono onorare come uno di loro, perché non sono uno di loro»; così scriveva Milani al suo avvocato, nominato d’ufficio nel processo per apologia di reato seguito alla pubblicazione nel marzo 1965 della Risposta ai cappellani militari, come ci ricorda un ex “ragazzo” di Barbiana, Michele Gesualdi, nel suo recentissimo Don Lorenzo Milani).
La professoressa di Milani è infatti nubile, pagata a cottimo, non va in ferie e non teme di infliggere punizioni corporali ai discenti.
Se «ognuno di voi sapesse che ha da portare innanzi a ogni costo tutti i ragazzi e in tutte le materie, aguzzerebbe l’ingegno per farli funzionare. Io vi pagherei a cottimo. Un tanto per ragazzo che impara tutte le materie. O meglio multa per ogni ragazzo che non ne impara una. Allora l’occhio vi correrebbe sempre su Gianni. Cerchereste nel suo sguardo distratto l’intelligenza che Dio ci ha messo certo eguale agli altri. Lottereste per il bambino che ha più bisogno, trascurando il più fortunato, come si fa in tutte le famiglie. Vi svegliereste la notte col pensiero fisso su lui a cercare un modo nuovo di far scuola, tagliato su misura sua. Andreste a cercarlo a casa se non torna» pur di riportarlo a scuola dove, Milani non lo esclude, può attenderlo lo scudiscio: «Noi per i casi estremi si adopra anche la frusta. Non faccia la schizzinosa e lasci stare le teorie dei pedagogisti. Se vuol la frusta gliela porto io, ma butti giù la penna dal registro. La sua penna lascia il segno per un anno. La frusta il giorno dopo non si conosce più».
Ma per poter intravedere, indovinare nello «sguardo distratto l’intelligenza che Dio ci ha messo» occorrono insegnanti missionari, che coltivino una scelta radicale e totalizzante, reclusi nelle loro scuole tutto l’anno («offrite il vostro doposcuola anche alle elementari e anche la domenica e nelle vacanze di Natale, Pasqua e estive»); la scuola a tempo pieno «presume una famiglia che non intralcia. Per esempio quella di due insegnanti, marito e moglie, che avessero dentro la scuola una casa aperta a tutti e senza orario. Gandhi l’ha fatto. E ha mescolato i suoi figlioli agli altri al prezzo di vederli crescere tanto diversi da lui. Ve lo sentite? L’altra soluzione è il celibato. È una parola che non è di moda. Per i preti la Chiesa l’ha capita circa mille anni dopo la morte del Signore. Gandhi l’ha capita, proprio in vista della scuola, a 35 anni (dopo 22 di matrimonio). Mao ha additato all’ammirazione dei compagni un operaio che s’è castrato (i “cinesi” italiani si vergognano a raccontarlo). A voi vi ci vorranno altri mille anni per adottare il celibato. Ma c’è una cosa che potete far subito: cominciate intanto a dirne bene e valorizzare i celibi che avete […]. Perché non dire agli altri e a se stessi che non è una disgrazia, ma una fortuna essere disponibili alla scuola a tempo pieno? Si usa dire, non so che con fondamento, che oggi i celibi son gli insegnanti meno umani. Domani quando fosse una scelta generosa potrebbero appassionarsi alla scuola, amare i ragazzi e essere amati. E soprattutto aver la gioia d’una scuola che riesce».
Ma Milani disperava che una scuola del genere potesse trovare sostenitori. Non nutriva fiducia né nello Stato centrale («finora si diceva che la scuola statale è un progresso rispetto alla privata. Ora bisognerà ripensarci e rimettere la scuola in mano d’altri») né nelle amministrazioni locali né nelle forze politico-sindacali, comunisti compresi («se la sentiranno d’urtare gli impiegati e i bottegai?»), e tantomeno negli insegnati (la maestra è «sposa e madre esemplare. A ogni raffreddore del bambino resta a casa. Chi non la piglierebbe una moglie così?»).
La Lettera a una professoressa veniva data alle stampe nel 1967. Cinquant’anni e pure sembra ieri. Certo, può apparire arbitrario ipotizzare un giudizio sulla situazione odierna da parte di chi non c’è più. Eppure non ci sembra azzardato supporre che Milani avrebbe avuto parole di fuoco anche per gli insegnanti di oggi.
Le attenuanti, non c’è dubbio, ci sono e non di poco conto: stipendi bassi e scarso riconoscimento sociale del ruolo svolto. In più, l’incremento del tempo pieno al Sud, da più parti richiesto per contrastare la dispersione scolastica, potrebbe rendere meno pressante la necessità di trasferire insegnanti nelle scuole statali centro-settentrionali dove negli ultimi vent’anni il numero di alunni è aumentato di quasi 800 mila unità (mentre il Meridione e le isole hanno perso circa 500 mila studenti). Ciò non toglie che il quadro tratteggiato nel rapporto del 2017 sulla mobilità docenti, pubblicato sul portale tuttoscuola.com, dovrebbe far arrossire dalla vergogna i suoi protagonisti: governo, sindacati e (non pochi) insegnanti.
Il tasso di mobilità di questi ultimi, che negli anni scorsi era di uno a dieci, nel 2016-2017 è esploso, triplicandosi, costringendo ad ammainare la bandiera della continuità didattica, fino a ieri da tutti brandita (con le conseguenti ricadute non proprio benefiche, immaginiamo, sui livelli di apprendimento degli allievi). È l’effetto del piano straordinario di mobilità previsto dalla “Buona Scuola” di due anni fa, preliminare, spiega il rapporto, «al varo del piano straordinario di assunzioni voluto dal Governo Renzi. In pratica un’“ultima chiamata” che doveva consentire al personale docente di spostarsi sulla sede più gradita anche “in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”. Fatta questa sorta di “condono”, doveva partire la nuova modalità di assegnazione della sede di servizio, la cosiddetta “chiamata diretta”: non sarebbe stato più il docente a scegliere la scuola, ma la scuola a scegliere il docente. È quanto prevede la legge ma l’accordo sulla mobilità firmato dalla ministra Fedeli con i sindacati allo spirare del 2016 prevede una nuova deroga da ogni vincolo di permanenza per tutti i docenti di ruolo, compresi quelli chiamati con incarico triennale dai dirigenti scolastici».
Per ora i numeri ci dicono che dei 207 mila insegnanti di ruolo nelle scuole statali trasferiti nel 2016-2017, almeno 130 mila sono docenti meridionali che dal Nord si sono avvicinati a casa: «Se in molti hanno parlato la scorsa estate di “deportazione” di docenti dal Sud al Nord, quello che è avvenuto con i trasferimenti è stato un vero e proprio controesodo di docenti meridionali che avevano preso il “ruolo” (cioè il posto stabile) al Nord e poi hanno colto l’occasione per chiedere il trasferimento verso casa. Back home».
All’indomani dell’Unità d’Italia, schiere di insegnanti “piemontesi” furono inviate nei comuni meridionali per procedere ad alfabetizzazione e Nation Building. Altra temperie storica, certamente; l’idea dello Stato-Nazione era allora la stella polare, l’alfa e l’omega del discorso pubblico e del sentimento identitario. Nonostante ciò è proprio necessario arrendersi alle miserie corporative e ai vittimismi lacrimevoli di chi ha perso qualsiasi senso dello Stato? Perché solo di questo, in fondo, si tratta; di mortificazione dei più basilari princìpi di solidarietà nazionale a opera di chi (governo e sindacati) quella mortificazione consente e di chi (insegnanti), approfittando del cavallo di Troia della Norma, quella mortificazione oggettivamente persegue.
Cosa accadrebbe, infatti, se nelle altre branche dell’amministrazione statale (forze di polizia, sanità, giustizia) nel corso di un solo anno un terzo del personale abbandonasse la sede assegnatagli, come è stato permesso che accadesse l’anno scorso nella scuola? Lo Stato semplicemente collasserebbe. Questo sarebbe il risultato: la somalizzazione del Paese. Un altro, l’ennesimo, Stato fallito, una carcassa gettata lì, esangue, in mezzo al Mediterraneo.
Destino ineluttabile? Forse no, purché coloro che quel destino vogliono scongiurare inizino a chiamare le cose con il loro nome e, quindi, a qualificare l’atteggiamento di coloro che quel destino rincorrono per quello che è: antipopolare e antinazionale.
Luca Tedesco, autore di questo articolo, è professore associato in Storia contemporanea all’Università degli studi Roma Tre
Foto Ansa
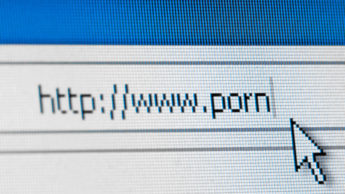


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!