
Il superbo “pasticcio” di De Gregori e Zalone
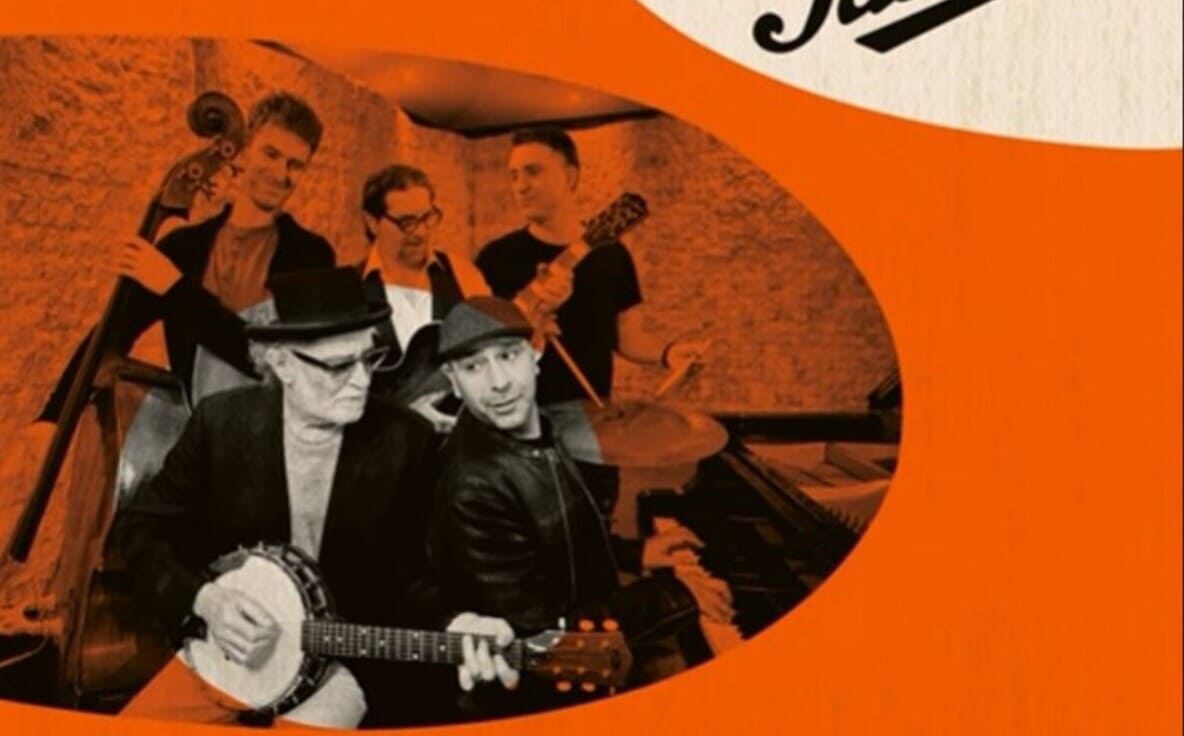
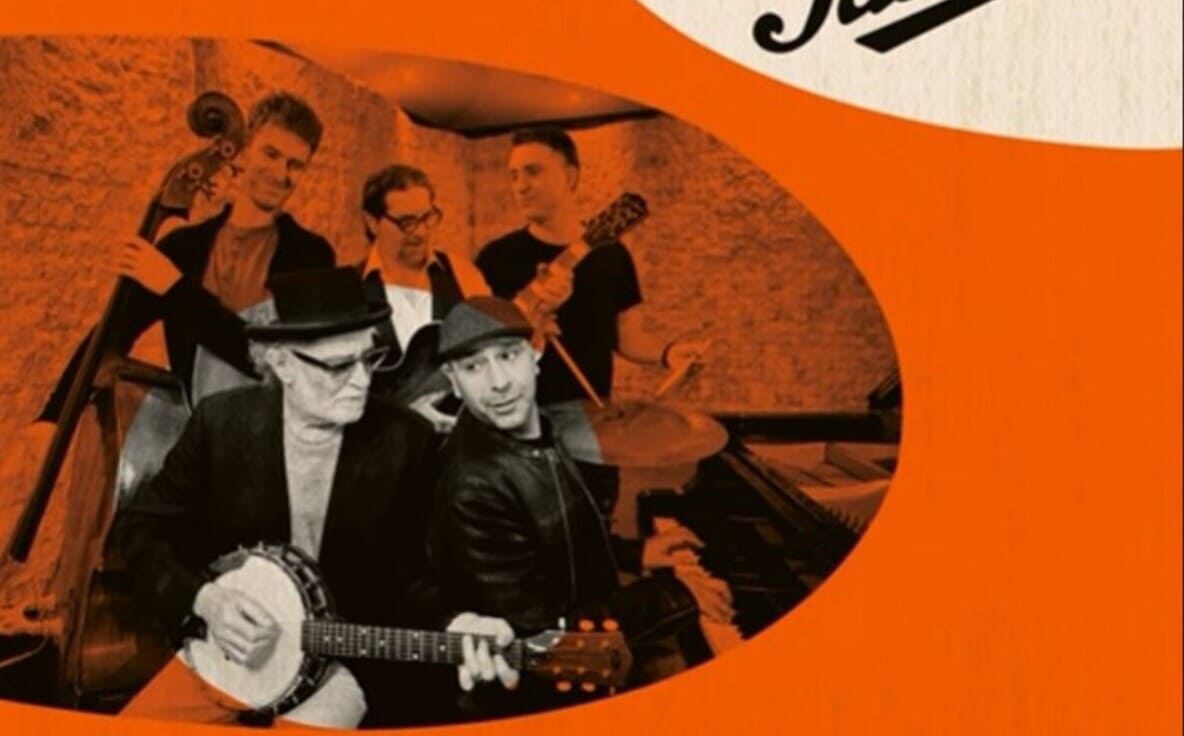 Si sono annusati a lungo Francesco De Gregori e Checco Zalone, si sono riconosciuti come due Maverick, cani senza collare, e alla fine hanno deciso di fare un disco insieme. Da qualche giorno è uscito Pastiche, album in cui il cantautore romano è accompagnato al piano da Luca Medici (vero nome del regista, comico e musicista barese). Sedici canzoni un po’ sue e un po’ di altri per una scaletta volutamente disordinata.
Si sono annusati a lungo Francesco De Gregori e Checco Zalone, si sono riconosciuti come due Maverick, cani senza collare, e alla fine hanno deciso di fare un disco insieme. Da qualche giorno è uscito Pastiche, album in cui il cantautore romano è accompagnato al piano da Luca Medici (vero nome del regista, comico e musicista barese). Sedici canzoni un po’ sue e un po’ di altri per una scaletta volutamente disordinata.
Un superbo “pasticcio” che va dal Paolo Conte di Pittori della domenica al Pino Daniele di Putesse essere allero, dal Venditti di Le cose della vita fino al Nino Manfredi di Storia di Pinocchio, scritta da un ventunenne De Gregori (che rinunciò ai diritti) per il film con cui nel ’72 Luigi Comencini mise in scena il romanzo di Collodi. Tra versioni intriganti e jazzate di Rimmel, Atlantide, Buonanotte Fiorellino e Pezzi di vetro, tra brani ridanciani (di Zalone) cantati a due voci, con Giusto o sbagliato, inedito lanciato in anteprima, De Gregori trova il modo di omaggiare anche il Sinatra di My Way.
Zalone – Politically correct: 6-0 6-0
«Un giorno mi trovavo a Bari», racconta De Gregori, «e cominciai a chiedere a ogni persona che incontravo se per caso avesse il numero di Checco Zalone. Volevo conoscerlo. Alla fine uno che aveva il suo numero lo trovai. Non vedevo l’ora di averlo accanto come musicista in questa strana e bellissima avventura». Amicizia e stima reciproca, certo, ma per capire davvero cosa lega questi due fenomeni così lontani (e così vicini) bisogna guardare fisso negli occhi quel politically correct e quel wokismo ai quali entrambi non sono solo allergici ma che appena possono si divertono a mettere alla berlina.
Sull’esplosivo “espressionismo comico” di Zalone parlano i suoi film e le sue performance da guitto. La maestria con cui si prende gioco dell’artefatto e affettatissimo mal di vivere dei rapper con autotune è una boccata d’aria fresca («Che ne sai di me? / delle gioie mie represse / dei miei iPhone 5 senza la S»). Stesso trattamento – nei panni di Oronzo Carrisi – il comico l’ha riservato ai pavoneggianti virologi nostrani, quelli che malgrado ogni sforzo non sono riusciti a celare il rimpianto per pandemia e comparsate tv («La curva è andata giù, sta per finire il sogno / Nessuno si spaventa più, manco a Codogno»). Lo spot in cui Zalone dona soldi alla ricerca (purché il ragazzo in sedia a rotelle guarisca in fretta e liberi l’agognato posto-auto) ha probabilmente segnato una svolta nelle simil Pubblicità progresso.
Mentre nel mondo lgbtq+ si è scatenato un vero e proprio terremoto col suo brano-cult, I uomini sessuali (qui cantata insieme a De Gregori, 10 anni fa, in un’esilarante improvvisata alla Feltrinelli di Bari), i quali, recita il brano, «non c’avranno gli assorbenti / ma però c’hanno le ali».
«Ci accomuna un senso etico senza moralismi»
Zalone – cosciente che il politicamente corretto in comicità è una solenne fregatura – lamenta che «c’è sempre qualche comunità o qualche gruppo di interesse che si offende». Naturalmente sul tema l’ironia abbonda: «Non sono razzista neanche verso i salentini, che per noi baresi sono i veri terroni». Eppure chiamare Oreste una trans, sul solenne palco di Sanremo, oggi in più di un paese oggi può significare la galera (vedere alla voce misgendering). Ma è proprio la comprensione della gravità del momento, il rifiuto di chiamare le cose col loro nome nelle piccole come nelle grandi cose, a spingere Luca Medici a osare di più, tanto che la collaborazione col cantautore romano si regge, come affermano entrambi, su un «senso etico senza moralismi».
Con queste premesse collocare politicamente il regista barese rimane assolutamente secondario. Più coerente, se così si può dire, divagare sulla leggenda che lo circonda, ovvero l’essere un “uomo di destra”, con l’ennesima gag: «Eravamo a una festa di paese. Tentavo di provare sul palco, ma da quattro ore un gruppo di comunisti, vestiti da comunisti, andava avanti con la pizzica. A un tratto mi venne spontaneo urlare: “Viva Berlusconi!”. Quel giorno nacque la Taranta de lu Centrudestra».
De Gregori difende gli “impresentabili”
Di altra natura, ovviamente, le “scorrettezze” di Francesco De Gregori. Era il 2017 quando l’“impresentabile” Trump vinceva le elezioni mandando ai matti l’America che conta. Il cantautore allora commentò parlando di «un’area liberal lontana dai problemi della realtà», di «una rincorsa acritica alla globalizzazione e soprattutto un’ansia estetica del politicamente corretto che personalmente ho sempre trovato insopportabile». Sulla necessità, poi, di continuare ad accogliere centinaia di migliaia di stranieri «puoi convincere un bostoniano, ma con un abitante dell’Ohio e in certe realtà sociali disperate fatichi di più».
Su Berlusconi, per decenni pietra di scandalo, il cantautore si espresse così: «Ho seguito con crescente fastidio e disinteresse l’accanimento sulla sua vita privata». E ancora: «Pensare di eliminare Berlusconi per via giudiziaria credo sia stato il più grande errore di questa sinistra (…) Mi irrita sentir parlare di “regime berlusconiano”: è una falsa rappresentazione, oltre che una mancanza di rispetto per gli oppositori di Castro o di Putin che stanno in carcere».
«Il nostro maestro invecchiato male»
De Gregori certificò poeticamente (e definitivamente) la sua voglia matta di smarcarsi da tutti con un brano del 2001, Il Cuoco di Salò, il cui ritornello così recita: «In una grande giornata si muore / Dalla parte sbagliata / In una bella giornata di sole / Qui si fa l’Italia e si muore». Versi che piacquero a Luciano Violante, il primo a rompere il tabù sui giovani repubblichini («Mi chiedo», disse nel ’96 in occasione del discorso inaugurale da presidente della Camera, «se l’Italia di oggi non debba cominciare a riflettere sui vinti di ieri»).
In questi anni in mille altri modi e in ogni occasione utile il cantautore romano ha continuato a lavorare ai fianchi un conformismo ideologico nei confronti del quale la sua insofferenza andava visibilmente crescendo. Fino ad arrivare a sorridere – in un’intervista a Aldo Cazzullo il cui rumore non si è ancora spento – di una sinistra ipnotizzata «dall’idolatria per le piste ciclabili», supina a «un sindacalismo vecchio stampo, novecentesco». Un sinistra «che si commuove per lo slow food e poi magari, “en passant”, strizza l’occhio ai No Tav per provare a fare scouting con i grillini». «Tutto questo», chiosava De Gregori in una conversazione che il Corriere si guardò bene dal richiamare in prima pagina (ma che Tempi riprese), «non è facile da capire, almeno per me».
I destinatari non la presero bene. Gad Lerner gli diede del «noioso e sopravvalutato», mentre una decina di Giovani Democratici – da Michele Anzaldi a Davide Faraone – scrissero una nota grondante pateticità: «Caro maestro, ti preghiamo di riprovare a crederci. (…) Noi conserveremo l’intervista, la ricorderemo come un errore e una critica eccessiva, tenendo a mente che non è da un calcio di rigore sbagliato che si giudica un giocatore». Malgrado la prosa salivante la lettera aperta non riuscì a mascherare fino in fondo l’astio per il “traditore”: «Non possiamo credere che il nostro maestro sia invecchiato così male».
“La cultura del piagnisteo”
Proprio Pastiche, invece, da superba gemma musicale qual è, racconta di un De Gregori che invecchia benissimo, e che trasforma ogni suo intervento, musicale o meno che sia, in una festa dell’intelligenza. Intervistato da Vanity Fair, alla domanda su sessismo, patriarcato e dintorni, il cantautore arriva a consigliare un saggio che la dice lunga sulla sua weltanschauung: La cultura del piagnisteo di Robert Hughes, per il cantautore «un libro fondamentale sulle follie del politicamente corretto». «Noi al tempo ci siamo annusati, cercati e amati senza farci del male», confessa De Gregori, «anzi facendoci spesso del bene, e sulle rispettive intenzioni – mi creda – ci siamo chiariti molto prima che la situazione degenerasse».
Per essere ancora più chiaro, l’autore di Rimmel dettaglia il saggio di Hughes: «Lì si racconta che un signore va in un caffè, apre la sua copia di Playboy e quando arriva la cameriera e sulla pagina, servendo un pezzo di torta, vede una donna nuda, denuncia il cliente per molestie. Così, a quei patti, ammetto di non farcela».
Pro life come l’amato Pasolini
La libertà del Principe (così i fan chiamano De Gregori) viene a galla da frammenti lasciati cadere qua e là; tasselli di un mosaico affascinante, di un approdo intellettuale che visto il peso specifico del soggetto incuriosisce e fa scuola, e che il cantautore-poeta vive con orgoglio, sapienza e spiazzante leggerezza. L’amicizia con Giuliano Ferrara (De Gregori è un “fogliante” della prima ora), quella con suor Rosalina Ravasio (fondatrice di quella Comunità Shalom che a Palazzolo sull’Oglio, rifiutando ogni aiuto di Stato, ha fatto rinascere migliaia di ragazzi ridotti dalla droga a zombie); l’amore per Cormac McCharty («specie le prime opere e la Trilogia della frontiera», precisa); la stima sia per Benedetto XVI («Il suo discorso di Ratisbona fu un discorso importante») che per Papa Bergoglio («La più bella notizia degli ultimi anni»).
Eppoi una certa idiosincrasia verso il ’68, nonché quella – ancor più coraggiosa – verso l’aborto e la sua glorificazione. «Sottolineando la sua grande ammirazione per Pasolini, ha dichiarato di condividere oggi – dopo che negli anni Settanta si era dichiarato profondamente contro – la posizione dell’intellettuale scomparso a proposito dell’aborto, che cioè esso non sia “un diritto civile”», così Paolo Vites, giornalista musicale e amico di vecchia data del cantautore. Un coerente “pastiche” di scoperte, incastri e incanti figli di un irrefrenabile amore per verità e libertà (nessuno si senta offeso).



0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!