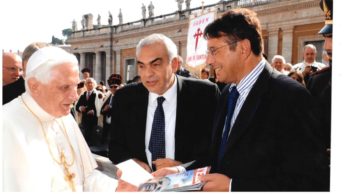
Questa Terra ci è sempre stata stretta


Articolo tratto dal mensile (qui come abbonarsi) – All’inizio il presidente degli Stati Uniti, Dwight Eisenhower, cercò di minimizzare, poi si rese conto che era impossibile. Ogni sera milioni di americani uscivano di casa e col naso rivolto all’insù, in religioso silenzio, indicando con l’indice, ammiravano stupiti il simbolo della potenza dell’Unione Sovietica fluttuare velocemente fra le stelle fino a scomparire dall’arco visivo. Si erano convinti addirittura che la tecnologia russa fosse più avanzata di quella americana e in tempi di Guerra fredda lasciare che una simile convinzione dilagasse tra la gente era pericoloso. All’apparenza si trattava solo di una delle tante luci che brillavano sfrecciando rapidamente in mezzo a un mare sterminato di altri astri immobili. Ma questa volta era diverso. Non era il solito aereo, ma il primo satellite mai lanciato nello spazio dall’uomo, lo Sputnik 1. Sono passati esattamente 60 anni da quando quella piccola sfera di metallo è rientrata nell’atmosfera dopo aver compiuto 1.440 orbite intorno alla Terra. I russi assestarono altri due colpi sotto la cintura agli americani, inviando nello spazio il primo animale e il primo uomo. Poi arrivò John Kennedy e nel 1961 giurò che «prima della fine del decennio faremo atterrare un uomo sulla Luna». In tanti gli avranno riso dietro, ma nel 1969 arrivò il lancio dell’Apollo 11. Il 20 luglio Neil Armstrong e Buzz Aldrin calpestarono il suolo lunare, riaffermando il primato a stelle e strisce. L’America inviò sul satellite naturale della Terra altri 10 uomini. L’ultimo vi mise piede nel 1972, poi più niente. La competizione si spostò su altri fronti e per quanto l’interesse scientifico di nuovi viaggi sulla Luna fosse incalcolabile, nessun governo aveva intenzione di spendere 150 miliardi di dollari per la scienza. Gli Stati Uniti affrontarono un viaggio di 385 mila chilometri per mostrarsi più forti di un paese che ne distava appena ottomila. Raggiunsero la Luna per affermarsi sulla Terra. Partirono alla scoperta dell’universo per riappropriarsi del mondo. Dopo aver raggiunto l’obiettivo, l’interesse internazionale per i viaggi spaziali è scemato. Fino a quest’anno almeno, perché il lancio in orbita, destinazione Marte, di una Tesla Roadster decappottabile da 200 mila dollari ha dato il via a una nuova corsa globale alla conquista dello spazio.
Il primo passo lo ha fatto Elon Musk, partorendo un’idea a metà tra sogno visionario e inedita fonte di ottimi affari. L’imprenditore sudafricano di 46 anni, naturalizzato statunitense, ha inviato a febbraio nello spazio con la sua società SpaceX il primo razzo da carico privato nella storia dell’astronautica. Il Falcon Heavy è anche il razzo più potente mai costruito al mondo e viaggia appunto verso il Pianeta rosso con un’automobile a bordo, guidata da un manichino vestito da astronauta che ascolta alla radio l’indimenticabile capolavoro di David Bowie: Life on Mars. Bastano questi dettagli per capire che Musk non è solo un bravo imprenditore, ma anche un re Mida capace di spettacolarizzare tutto ciò che tocca. La lezione di Steve Jobs, l’ha imparata benissimo: così l’obiettivo della Tesla, l’azienda di sua proprietà specializzata nella produzione di veicoli elettrici, non è banalmente quello di produrre bolidi belli e sicuri, ma di «accelerare la transizione del mondo verso l’energia sostenibile». Allo stesso modo, SpaceX non mira solo a costruire razzi superpotenti, ma a «rendere l’umanità una specie multiplanetaria». Visione, dunque, ma sempre con un occhio rivolto al portafoglio.
Un razzo fottutamente enorme
A nove anni dal suo primo lancio, SpaceX invia regolarmente satelliti in orbita, porta rifornimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) e soprattutto ha reso tutto questo “economico”, testando con successo una tecnologia che permette dopo il lancio di far tornare sulla Terra le parti più costose dei razzi, pronte per essere riutilizzate. Il settore aerospaziale, secondo il visionario Musk, è costoso solo perché manca la tecnologia: «Immaginate se una compagnia aerea gettasse via i suoi aerei dopo ogni volo, quanto pensate che costerebbe?», disse nel 2011.
L’imprenditore è molto ambizioso e non sogna appena di «colonizzare Marte», ma anche di guadagnarci. Il progetto è questo: investire 10 miliardi di dollari per costruire un unico tipo di razzo (il cosiddetto BFR, “Big Fucking Rocket”, cioè “Un razzo fottutamente enorme”) e un’astronave da 100-200 posti da utilizzare per missioni e scopi diversi. Nel 2022 dovrebbero partire i primi viaggi pilota verso Marte, nel 2024 sarebbero inviate quattro astronavi, due delle quali con un primo equipaggio di coloni «pronti anche a morire», incaricati di costruire una base. Per rendere più semplice il viaggio di 382 milioni di chilometri, tanto dista il Pianeta rosso dalla Terra, Musk vorrebbe fare tappa sulla Luna (“appena” 400 mila chilometri). Nel frattempo, per raggranellare qualche milione, ha intenzione di portare privati cittadini a fare un giretto attorno al satellite naturale. Due candidati, ha rivelato, hanno già pagato intorno agli 80 milioni di dollari per il primo viaggio, che avverrà «entro la fine del 2018». A medio termine, invece, l’imprenditore vorrebbe utilizzare l’astronave per i viaggi intercontinentali: per percorrere gli 11 mila chilometri che separano New York da Shanghai, giura, basterebbero 39 minuti.
Si potrebbe pensare che Musk sia semplicemente un pazzo e forse è così, ma non è certo l’unico. Il fondatore di Virgin Group, l’eccentrico Richard Branson, proprietario di oltre 400 aziende nei settori più disparati, dalla discografia al trasporto aereo, effettuerà viaggi spaziali suborbitali per privati a partire da quest’anno. Al contrario della capsula Dragon di Musk, la navicella VSS Unity non viene mandata in orbita con un razzo ma con l’aiuto di un aereo-madre. Una volta trasportata fino a 16 mila metri da terra, la navicella accenderà i motori per oltrepassare la “linea di Karman”, il confine convenzionale con lo spazio a 100 chilometri di altezza. La VSS Unity non è in grado di effettuare un’orbita completa intorno alla Terra e dopo una breve permanenza nello spazio, ricadrà nell’atmosfera. Nella sua lista d’attesa ci sono già 700 ricchissimi viaggiatori, disposti a spendere 250 mila dollari per un posto a bordo. Tra di loro, figurano anche vip come Brad Pitt.
Nella corsa privata alla conquista dello spazio ci sono altri due concorrenti. Il primo è Jeff Bezos, proprietario di Amazon e di Blue Origin, che porterà danarosi cittadini in orbita «nel 2018 e in ogni caso non più in là del 2019». Per finanziare i test del suo razzo sta vendendo ogni anno azioni di Amazon del valore di un miliardo di dollari. Lo scopo finale è entrare nel business del lancio dei satelliti, mentre ogni singolo viaggio privato costerà centinaia di migliaia di dollari. Il secondo concorrente è Paul Allen, cofondatore di Microsoft assieme a Bill Gates, che ha finanziato e progettato lo Stratolaunch, l’aereo più largo del mondo che sarà in grado a partire dal 2019 di mandare in orbita satelliti senza bisogno di utilizzare rampe di lancio o strumentazioni a terra.
Una nuova Guerra fredda
In una sorta di nuova Guerra fredda economica, anche i russi vogliono sfruttare il business dello spazio. Vladimir Solntsev, leader della compagnia aerospaziale russa Energia, che ha inviato il primo uomo nello spazio nel 1961, ha infatti dichiarato a gennaio che presto dei privati cittadini potranno camminare tra le stelle come veri astronauti, sfruttando la piattaforma della Iss alla modica cifra di 80 milioni di dollari, per un’esperienza della durata di dieci giorni. Per riposarsi dalle fatiche quotidiane i facoltosi potrebbero alloggiare nell’hotel a cinque stelle che Roscomos, l’agenzia spaziale russa, ha intenzione di costruire sulla Iss entro il 2022. Una matrimoniale extra-lusso costerà 35 milioni di dollari, ma sarà dotata di finestre con vista Luna.
L’esplosione del business dei viaggi spaziali non è un caso. Nel 2015 gli Stati Uniti hanno approvato lo Space Act, che dà ai cittadini a stelle e strisce «pieno diritto di possedere, trasportare, utilizzare e rivendere quelle risorse reperite a titolo commerciale su un asteroide o nello spazio». La prospettiva fa gola a molti, anche in altri parti del mondo: Emirati Arabi Uniti e Lussemburgo hanno approvato legislazioni simili. E il rinnovato interesse per il Sistema solare è proprio anche degli Stati nazionali. Il 2018 non vedrà solo qualche centinaio di ricchi annoiati orbitare intorno alla Terra sorseggiando cocktail, ma anche conquiste inedite dal valore, tecnologico e politico, enorme. È il caso, innanzitutto, della Cina. A 45 anni dall’uscita del famoso disco dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, quest’anno l’uomo raggiungerà per la prima volta il cosiddetto “lato oscuro” della Luna, la faccia cioè che il nostro satellite naturale non ci mostra mai nella sua orbita. E sarà un rover cinese a farlo. Pechino non si accontenta più di essere la seconda superpotenza mondiale dal punto di vista economico e politico. La Terra ormai le va stretta e la rinnovata volontà di potenza del partito comunista desidera affermarsi anche nell’universo, dimostrando di non aver nulla da invidiare a Stati Uniti e Russia. La missione Chang’e 4, dal nome della dea lunare cinese, si dividerà in due fasi: la prima partirà a giugno e posizionerà un satellite 60 mila chilometri dietro la Luna per assicurare le comunicazioni con la Terra. Una volta stabilito il collegamento, verrà lanciato il lander incaricato di atterrare sul satellite naturale.
Ipotetico conflitto spaziale
Riuscire là dove nessuno è mai arrivato è solo il primo passo per il Dragone. A gennaio si è concluso il periodo di 200 giorni che quattro studenti cinesi hanno passato in un laboratorio costruito per l’occasione, e chiamato Yuegong o “Palazzo lunare”, che simula la vita sul corpo celeste. Oltre a verificare la tenuta delle persone allo stress di una esperienza claustrofobica e senza luce solare, sono state testate speciali coltivazioni al chiuso per assicurare all’equipaggio dosi di cibo sufficienti nel caso ci sia un imprevisto blocco dei rifornimenti dalla Terra. La Cina, infatti, sta progettando di costruire un avamposto umano permanente sul satellite, un vero e proprio “villaggio lunare” che potrebbe servire da base per future esplorazioni dello spazio. Uno degli obiettivi dichiarati del presidente Xi Jinping è di raggiungere Marte entro il 2020, come confermato da Wu Weiren, a capo delle missioni cinesi: «Il nostro obiettivo a lungo termine è esplorare, atterrare e stabilirci sulla Luna». Le mosse di Pechino inquietano molti Stati, soprattutto perché il Dragone, al pari di Usa, Russia e Francia, non ha mai ratificato il Trattato sulla Luna del 1979, che la riconosce patrimonio dell’Umanità e ne vieta la privatizzazione. Un recente rapporto dell’Fbi, inoltre, ha lanciato un allarme che può apparire singolare: nei prossimi anni Pechino e Mosca si doteranno di «armi distruttive» da utilizzare in un «ipotetico conflitto spaziale» in grado di abbattere tutti i satelliti dei paesi nemici.
Fantascienza? Forse. Resta il fatto che il presidente Donald Trump, sorprendendo la stampa, ha annunciato alla fine dell’anno scorso che la prossima destinazione degli astronauti americani «sarà la Luna»: «Vi faremo ritorno per la prima volta dal 1972 per esplorazioni scientifiche ma non solo», ha dichiarato alla Casa Bianca. «Stavolta non ci limiteremo a piantare la nostra bandiera, ma stabiliremo una fondazione per altre future missioni». Gli Stati Uniti non sono gli unici che non intendono restare a guardare mentre la Cina progetta di conquistare questo o quel corpo celeste. L’India, principale avversario asiatico del partito comunista cinese, si è alleata con il Giappone per sviluppare un programma di «esplorazione lunare, osservazione della Terra e navigazione satellitare». L’obiettivo è esplicito: «Tokyo e New Delhi saranno i leader della regione asiatica nel settore spaziale». Il primo passo consiste nell’inviare un veicolo quanto prima proprio sulla Luna. La Russia, oltre a progettare fantastici hotel, quest’anno testerà un nuovo motore nucleare in grado di rivoluzionare per sempre i viaggi nello spazio: la tecnologia potenzierebbe a tal punto le astronavi da permettere di raggiungere Marte in sole sei settimane, contro i 18 mesi attuali.
Alla corsa si sono iscritti anche paesi a prima vista improbabili. Dubai sta sviluppando un programma e intende lanciare la sua prima missione verso Marte entro il 2021, nella speranza di stabilirvi una colonia tra 99 anni, nel 2117. Per simulare la vita sul Pianeta rosso è in costruzione nel deserto una mega città, che sarà parzialmente completata nel 2020. Sognare non costa nulla, ma gli Emirati Arabi Uniti hanno già investito oltre 6 miliardi di euro nel programma, che prevede quest’anno il lancio del primo satellite progettato e costruito da ingegneri arabi. Si chiamerà “KhalifaSat” e verrà mandato in orbita dal Giappone. Nessuno vuole rinunciare alla sua fetta di cielo e, se tutto andrà come previsto, sarà il Sudafrica a mandare in orbita il primo satellite privato africano (Angola, Egitto e Nigeria hanno già effettuato in passato lanci statali).
Perché vogliamo volare
Il 2018 segna la data iniziale di una nuova corsa allo spazio globale, dopo decenni di inattività e ordinaria amministrazione. Perché si è aspettato tanto? Vitaly Egorov, portavoce di Dauria Aerospace, azienda privata russa che costruisce satelliti per conto di Roscomos, ha la risposta: «Molte persone sono venute a chiedermi: “Possiamo replicare il successo di SpaceX?”. Tecnicamente, sì. Musk non ha fatto niente di eccezionale. I sovietici l’hanno fatto prima di lui e i russi possono farlo di nuovo. Dopo tutto, costruire un super razzo è un problema matematico. E noi non siamo certo a corto di matematici. Quello che ci manca sono i sognatori. Per sapere come volare e dove volare, abbiamo prima bisogno di sapere “perché” vogliamo volare».
Dal business dei viaggi privati alla conquista di Marte, dal mercato dei satelliti alla colonizzazione della Luna, dal sogno di una «specie multiplanetaria» alla brama di dominare il mondo, i “perché” oggi non mancano. Non saranno poetici come il desiderio di vedere «navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione o i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser». Ma in fondo, se la Russia non avesse voluto primeggiare sull’odiato nemico americano, non si sarebbe mai innescato quel processo che ha portato Neil Armstrong a compiere «un piccolo passo per un uomo, ma un balzo gigantesco per l’umanità».
Foto Ansa
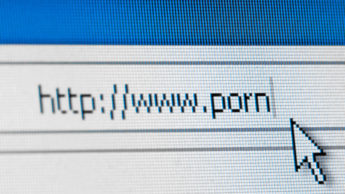


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!