
Una Repubblica fondata sul malinteso


Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – E se tutto diventasse davvero un dèjà dit, dèjà écrit, dèjà lu? Detto, scritto, letto? Scomparirebbero le lucciole linguistiche con il loro tic luminoso. Via anche abusati ossimori, solite metafore, la deriva lessicale di kafkiano e i «Sì ma tra virgolette accompagnato dall’agitar di dita». Via tutto il vuoto della lingua liquida, significanza di una politeia vera nel linguaggio ma surreale nella realtà. Ecco gli sperati effetti collaterali della lettura di Sillabario dei malintesi di Francesco Merlo (Marsilio). Il sillabario come lo scarto in avanti della lallazione, l’evoluzione dal fonosimbolismo al significato. Desemantizzare il reale è fraintendere il senso dei segni, male intendere. Il malinteso è deviazione del linguaggio, una malizia. Malintesi maliziosi, ci suggerisce Merlo nel suo libro con il sottotitolo “Storia sentimentale d’Italia in poche parole”: non un abbecedario per adulti ma una narrazione con tanto di sentimenti e di protagonista. Il sentimento è la malinconia, il protagonista è l’Italia.
Nel suo romanzo degli italiani Merlo affida il plot a un elenco di parole errabondo. Le parole rimandano ad altre parole di cui condividono il disordine spaziotemporale, vagando da un personaggio all’altro, da una memoria all’altra, ora collettiva ora privata. A tenere insieme le parole è la schizofrenia dell’italianità, incrocio di carattere e destino. La schizofrenia del quasi. In tempi difficili il “dire e non dire” è un’arma indispensabile. Lo sapeva già Manzoni dissimulando la lingua nei “fiori” di don Ferrante e nel latinorum del povero don Abbondio. Bei prototipi di italiani don Ferrante e don Abbondio! Oggi forse sarebbero il primo un esempio di cretinocrazia e il secondo il capitan codardo dell’inchino all’isola del Giglio. Nel loro carico di ironia i due caratteri di ieri e di oggi si portano addosso il malinteso dell’italica specie.
Caustico nelle riflessioni, anche quando cede ai ricordi, ed elegante nella penna, persino negli sfacciati esempi di turpiloquio, Merlo in settantanove voci ricostruisce la storia d’Italia da un referendum all’altro, dal 1948 al 2016, per dire che il malinteso è il nostro liquido amniotico. Sul malinteso materno suggerisce il più auspicabile degli effetti collaterali della scomparsa dei tic linguistici italioti: un malinteso che si rovesci in beninteso. La madre è sua madre che votò monarchia (prima parola del sillabario definita però alla voce “Stile”) a sua volta il seme occulto (segreto d’urna) della Patria. «Si può combattere una guerra senza avere una Patria?» si chiede Merlo mentre vede nella bandiera un «legame istintivo e cieco» come la mamma: la Patria è la madre, meglio la madrepatria, l’ossimoro degli ossimori d’Italia. Infine per didascalia all’ossimoro, da divertito cultore dell’iperbole linguistica, crea la parola Matria e chiude il cerchio cominciato coi ricordi politico-familiari-culinari della sua mamma e finito con la casa-nazione. «La matria è dunque l’appartenenza organica, il luogo d’origine e non il luogo d’arrivo».
Il culto della virgola
Si sospetta una trama borgesiana o calviniana con guizzi alla Montanelli anche per i filoni narrativi innestati sul tema materno. Primo il referendum da cui la matria è nata o sarebbe rinata. Il gerundivo impone un dovere e di per sé spinge a mancarvi. Il punto interrogativo del referendum è l’essenza del malinteso malizioso perché impone risposte sghembe. Dal referendum al gerundio “agenda”. Merlo si conferma maestro di calembour di pensieri: in agenda non si segna l’appuntamento con Sharon Stone né col principe azzurro, figurarsi una legge costituzionale! Poi c’è la parola divenuta parolaccia messa significativamente dopo “Tangente” (che ha svilito la maschera dello scroccone) e prima dell’endiadi “Fogna e grammatica”. Ricorda il pannellese, la parolaccia come libertà, antitesi del turpiloquio sbracato di Bossi e di Grillo e di quello tragicamente inopportuno di Scajola che diede del rompicoglioni a Marco Biagi. Mentre avanzano i populismi Merlo, in un altro dei suoi attraversamenti storico-linguistici, lancia una provocazione sulla parola popolo: «Ha smesso di significare ed è diventata la risorsa difensiva di teste confuse, il marchingegno retorico…».
A ordinare i pensieri di teste confuse basta una virgola? Alla virgola è dedicato il capitolo più gustoso. Si salvi la virgola dalla moltiplicazione geniale di Totò o dal «complotto chirurgico» di Joyce, anzi si inauguri il culto della virgola «pausa di ironia, scalo del marinaio, è il cielo in terra». Nel suo “quasi” manuale Merlo porta con sé ricordi di luoghi descritti con sorprendente accento lirico (lo smog di Milano e il mare di Acitrezza) e una folla di personaggi. Da alcuni sembra farsi prendere per mano: il padre e la madre, il nonno e il maestro, l’amico Oliviero Toscani e a loro modo Pannella, Kafka, Pasolini, Manzoni e Bufalino. Il ricordo di Bufalino è la chiave del libro: «Quando una lingua riesce a dire l’indicibile, qualsiasi altra spiegazione invece di sbrogliare imbroglia».
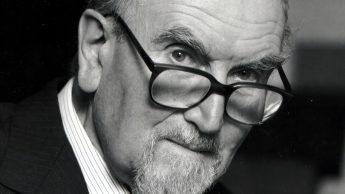


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!