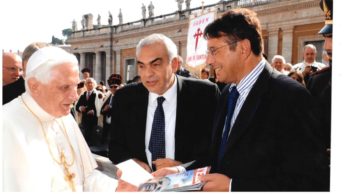
Vuoi capire i Big Data? Fai il Liceo classico


Cos’hanno in comune il liceo classico, il diventare uomini e i big data? Apparentemente niente, ma solo apparentemente. In realtà sono uniti da un filo rosso, impercettibile a prima vista, ma che li lega in maniera molto salda. In maniera diversa, ciascuna parola o concetto sottintende la ricerca di un “senso”. Se ne è parlato a Milano al convegno sabato 13 gennaio al convegno “Nella complessità odierna con il latino e il greco”, organizzato dalla Fondazione Grossman, in collaborazione con la Fondazione Sacro Cuore, per festeggiare i dieci anni del liceo classico Alexis Carrel.
UNA “STRANA” TAVOLA ROTONDA. «All’interpretazione della storia dell’Occidente – ha spiegato Giulia Regoliosi, preside del liceo classico – così importante in un mondo multietnico, si è aggiunto un compito urgente: capire il presente (cercarne cioè il senso) e saper operare in esso. Al logòs, all’uso della ragione, si deve affiancare la sophia, l’intelligenza creativa». Ecco allora che diventa possibile far sedere allo stesso tavolo figure fra loro diversissime, con un’unica cosa in comune e cioè l’aver frequentato il classico, come Moreno Morani (ordinario di linguistica storica all’Università di Genova), Matteo Brambilla (amministratore delegato di Omab Srl), Tommaso Montorfano (professore di lettere presso la Fondazione Sacro Cuore di Milano), Marco Fattore (docente in data Science presso l’Università Bicocca) e Giuseppe Pezzini (ricercatore in latino presso la University of St. Andrews, Uk). E la cosa diventa ancora più interessante se si pensa che si sono confrontati su un tema difficile: perché oggi, in una società liquida, è interessante frequentare, e proporre, il liceo classico?
LA RAGIONE. Da sottolineare l’intervento del neo arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che ha voluto far sentire la propria vicinanza e il proprio incoraggiamento rivelando di aver fatto lui stesso una tesi intitolata “L’insegnamento del latino come introduzione all’esegesi dei classici”. Ha anche confessato di «aver sognato di scrivere una grammatica su quegli insegnamenti, come fanatico sostenitore dell’importanza della cultura classica». Anche nelle parole di Delpini è riecheggiata più volte la parola “ragione” come possibilità di «aprirsi alla contemplazione scoprendo orizzonti su cui il mondo attuale rischia di rimanere troppo chiuso e di intristire, smarrendo il senso dell’umano e della speranza».
UN ATTO DI CORAGGIO. È stato un vero e proprio “atto di coraggio” secondo Giulia Regoliosi a spingere un gruppo di insegnanti e genitori ad aprire un altro classico a Milano, «città che vanta una tradizione lunghissima e prestigiosa». Alcuni interventi di Papa Benedetto XVI, in particolare quello a Ratisbona, «ci hanno lasciati indifferenti. Come non poteva non smuoverci il desiderio di offrire l’esperienza educativa lunga della nostra scuola anche a coloro che non avevano solo interessi scientifici».
DAL LATINO ALL’ITALIANO. Incalzati dalle domande e riflessioni del coordinatore del convegno, Enrico Castelli, si sono quindi confrontati Morani, Brambilla, Fattore e Pazzini.
Il primo ha posto l’accento sull’evoluzione che ha portato dal latino all’italiano senza che ci sia mai stata una vera e propria cesura. Il latino, dunque, non è un passato, ma un presente. E studiare il passato «significa immergersi in qualcosa che ampia la nostra lingua e collocare un soggetto in una prospettiva». Secondo Morani, mettendo a confronto presente e passato linguistico è possibile «cogliere dinamiche complesse e articolate di trasformazioni. E studiare latino è un modo per mantenere la nostra memoria, elemento fondante della nostra persona».
PERCHE’ STUDIARE LINGUE MORTE? Il professor Montorfano ha provato a rispondere alla domanda delle domande: perché nel 2018 un ragazzo dovrebbe studiare latino e greco, sempre più spesso definite lingue morte? «Lo studio della lingua – ha detto – è uno scoglio perché si ha un senso di insensatezza, perché non c’è nessuna utilità pratica in quanto manca un nesso con sé». «Approcciarsi al latino e al greco – ha continuato – diventa interessante se c’è una prospettiva strumentale». Il rischio di rimanere delusi, visto che i testi dei classici sono praticamente tutti già tradotti, è comunque dietro l’angolo. Ed ecco che si entra nel cuore della questione. Come uscire da queste secche? Sono tutte domande che chiedono un senso. E lo studio di una lingua, qualunque essa sia, diventa insopportabile «quando si sottrae all’esigenza di senso. Un’ipotesi di senso deve essere sperimentata da subito».
Perché leggere autori lontani da noi anni luce? «Per comprendere meglio l’attualità. Per imparare a essere uomini». Leggendo quei testi emergono le stesse domande che abbiamo noi oggi. Secondo Montorfano, questo non ci fa conoscere direttamente la nostra cultura, ma «aiuta a conoscere noi stessi e ci chiarisce quelle domande e quei problemi e ci fa reagire. Quindi l’impegno con quelle domande è l’impegno con la nostra vita, con la nostra umanità. Se la cultura classica non fa questo non è molto utile».
PASSIONE PER CIÒ CHE SI FA. Matteo Brambilla, amministratore delegato di un’azienda metalmeccanica, degli anni del Berchet ricorda un professore che «affascinava perché comunicava una passione per ciò che faceva». E poi l’amore al dettaglio come «scrupolosa lealtà metodologica nei confronti della realtà» e «l’attenzione ad osservare tutti i particolari senza tralasciare nessun indizio». Brambilla ha raccontato di essersi iscritto a Filosofia per cercare di rispondere alle domande che la realtà gli suscitava. «Volevo capire – racconta – perché avevo risposte frammentate. Le rielaboravo e volevo capire di più. Il tema del contenuto e del significato, del dettaglio e del senso è il tema che c’è in tutto». E l’impostazione del classico è stata ciò che gli ha consentito di guidare un’azienda che oggi ha più di 100 persone.
I BIG DATA. Si è arrivati così al tema dei Big Data: lontani anni luce, a prima vista, dagli autori classici. Marco Fattore invece è riuscito a spiegare quanto centrino gli uni con gli altri. Proponendo una slide incomprensibile di migliaia di numeri ha affondato il coltello. «Il mio problema non è fare calcoli, ma ricostruire testi. Quindi sintetizzare significati a partire da pezzettini». Dove si impara a fare questo processo di sintesi di una realtà frammentata? «Dalle domande sul senso di ogni cosa – ha abbozzato – e dall’imparare a interconnettere i segni. E la grammatica del classico è una palestra eccezionale di metodo. Poi serve una capacità di argomentare, di mettere insieme i pezzi». Questo vale ancora di più oggi immersi come siamo nella complessità, nell’IoT, nell’Internet of things. La diffusione estrema di dispositivi in grado di generare dati (a partire dallo smartphone che ciascuno di noi ha) ci “butta” in una realtà frammentata. E allora Fattore si è chiesto quale sia la figura umana protagonista di questo mondo? «È quella che capace di mettere insieme i pezzi – ha risposto – quella capace di senso. Servono una ragione ed una estetica forte. Abbiamo tanti frammenti e non riusciamo a vedere l’intero. Siamo in un mondo frammentato a tutti i livelli. Si frammenta la conoscenza. Abbiamo tanti dati astratti, ma frammentati che non producono cultura e conoscenza. Frammentiamo le relazioni e il tempo, l’agire è sempre più spesso legato all’efficientismo».
DOMANDA DI SENSO. Un quadro ricco di stimoli, ma dove lo spazio per il senso delle cose è sempre più stretto. Ecco la potenza del classico allora. «Occorre costruire ambiti capaci di generare personalità forti che abbiano la capacità di senso. Penso che la scuola giochi questa sfida a tutti i livelli e il liceo classico è un punto privilegiato in questa sfida. C’è bisogno di mettere nel mondo persone così, con questa domanda di senso. Altrimenti il futuro sarà fatto di automi. Al classico, attraverso lo studio e l’interlocuzione con la nostra storia, si impara quello che serve per entrare nel mondo. L’elemento distintivo del classico è che aiuta a riflettere sul senso del mondo, il mondo di oggi è fatto di diversi linguaggi e il classico fa crescere aiutando a integrare i linguaggi».
LA SFIDA DELL’INUTILITÀ. Il paragone con il mondo anglosassone proposto da Giuseppe Pezzini ha posto al centro dello scacchiere l’utilità (o l’inutilità) di iscriversi ad un liceo classico o a un corso di laurea in lettere classiche. La questione diventa ancora più importante nel Regno unito dove le scuole e le università «competono fra di loro in una logica di mercato come delle aziende vere e proprie». Il problema dell’attrattività e persuasività delle risposte è letteralmente una questione di vita e di morte. E quindi come possono gli studi classici aiutarci a vivere in questo mondo? Serve un approccio dialogico col mondo classico. E la lingua è lo strumento per il dialogo.
Oggi l’Alexis, come lo chiamano gli studenti, ha scalato posizioni e posizioni nella classifica di Eduscopio fino ad arrivare, in pochi anni, alla quarta posizione fra i migliori classici di Milano e Provincia. A cosa servirebbe un “quasi podio” se la scuola non fosse realmente un luogo di educazione? Un luogo cioè dove, nella libertà, è anzitutto interpellata l’autocoscienza dei giovani proprio a partire dalla loro ragione. Così è più chiaro perché nel classico, diventare uomini e big data sono strettamente legati fra loro.
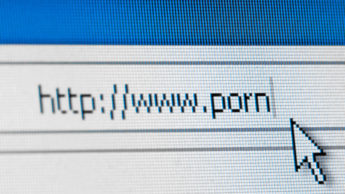


0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!